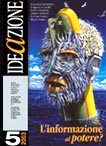|
|
|
|
|
Libri.
Alle radici della democrazia bloccata di Cristiana Vivenzio Che non fu vera truffa ormai sono tutti concordi, a destra come a sinistra. E quella legge di riforma elettorale che ormai cinquant’anni fa (era proprio il 1953) animava accesamente le aule parlamentari italiane sembra tornare periodicamente in auge, almeno ogniqualvolta a qualcuno non venga in mente di proporre una modifica all’attuale sistema elettorale che contemperi la stabilità del maggioritario con la rappresentatività del proporzionale. L’attualità di quella legge – passata alla storia come “legge-truffa” grazie ad una delle più efficaci campagne elettorali mai più realizzate dai partiti all’opposizione di sinistra e di destra – e la ricorrenza storica piena nonché la possibilità di accedere al materiale d’archivio relativo a quella vicenda della politica italiana danno conto del perché recentemente ha trovato la luce più di una pubblicazione dedicata nello specifico a quei primi anni Cinquanta. Tra queste le due monografie di Maria Serena Piretti (La legge truffa, il Mulino, 2003) e Gaetano Quagliariello (La legge elettorale del 1953. Dibattiti storici in Parlamento, il Mulino, 2003). Era il 1953 e il paese si trovava alla vigilia del primo importante confronto elettorale dopo il “plebiscito” democristiano del ’48. Le elezioni amministrative che si erano tenute nei due anni precedenti in tutt’Italia avevano mostrato la caduta dei consensi in favore del partito di maggioranza di governo, con la sostanziale tenuta dei partiti del Fronte popolare da una parte e la consistente avanzata dell’opposizione missina e anche monarchica (soprattutto nelle regioni del Sud) dall’altra. L’operazione Sturzo intentata per le elezioni al comune di Roma, anche se fallita, aveva reso evidenti le intenzioni di una parte non minoritaria dell’alto clero cattolico (il cosiddetto “Partito Romano”), che insisteva per uno spostamento a destra del baricentro della politica italiana, quando non per la costituzione di un vero e proprio partito antagonista alla Dc, che portasse avanti il mandato anticomunista con rinnovata forza. Al governo del paese De Gasperi, che aveva palesato in occasione delle amministrative romane la ferma intenzione di salvaguardare la sua strategia politica, aveva formato il suo VII esecutivo con l’appoggio dei soli repubblicani, a mostrare la fase di debolezza attraversata dalla formula centrista non solo per la posizione dei cosiddetti partiti laici ma anche a causa delle divisioni interne alla Dc. All’interno del partito di maggioranza esistevano, infatti, proposte alternative alla linea del leader trentino e alla sua scelta di governo. Linee che riemersero, venuta meno la necessità assoluta di fare innanzi tutto fronte alla minaccia comunista, rivendicando una maggiore valorizzazione del partito ed una maggior assunzione di potere a danno degli alleati minori, la cui azione politica troppo spesso si era dimostrata debole e altalenante. Mentre i partiti minori, che temevano un’eccessiva subordinazione alla Dc, vagheggiavano di poter costituire una “terza forza” politica aldilà della logica bipolare dei partiti di massa, pur rimanendo ancorati al partito di maggioranza per questioni di “sopravvivenza” politica. Da parte loro gli americani non allentavano la morsa della politica anticomunista e richiedevano ai leader democratici italiani di “prendere una ferma opposizione nei confronti del Pci”. L’amministrazione Truman ne fece ufficiale richiesta al leader democristiano nel settembre del 1951, nel corso del secondo viaggio che De Gasperi compì negli Stati Uniti, sostenendo la necessità di porre rimedio all’erosione elettorale subita dalla Dc e dai suoi alleati alle amministrative di quell’anno attraverso una serie di misure politiche ed economiche attuate in funzione anticomunista. La paura del blocco del sistema per l’opposizione congiunta di destre e sinistre ormai rafforzate dal consenso elettorale; le pressioni sempre più consistenti del Vaticano; le vivaci sollecitazioni degli Stati Uniti; la crisi dei partiti interni al sistema politico, sono queste solo alcune delle motivazioni che spinsero verso la riforma elettorale del ’53. Fallita la “legge-truffa”, in Italia non si è più riparlato di riforme elettorali per molto tempo, consacrando di fatto il parlamentarismo proporzionalista quale unico sistema costituzionalmente riconosciuto. Ma oggi c’è chi guarda a quella scelta degasperiana come ad un’occasione mancata. 5 novembre 2003 vivenzio@ideazione.com Maria Serena Piretti, La legge truffa, il Mulino, Bologna, 2003, p. 254, € 18. Gaetano Quagliariello, La legge elettorale del 1953. Dibattiti storici in Parlamento, Mulino, Bologna, 2003, p. 581, € 40. |
 |
||
| stampa l'articolo |
|
|