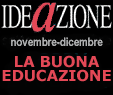Le
virtù del populismo
POPULISMO, OLTRE GLI STEREOTIPI
di Alessandro
Campi
In
Italia più che altrove il populismo gode, come suol dirsi, di una pessima
stampa e di una reputazione assai dubbia. Colpisce, in effetti, il
significato liquidatorio e dispregiativo che il termine – peraltro
controverso e sfuggente anche agli occhi degli studiosi – presenta nel
linguaggio comune, nel frasario degli uomini politici e nel vocabolario dei
mass media, allorché esso viene utilizzato per qualificare un movimento o
un partito, una presa di posizione o un orientamento. Nelle discussioni
politiche, l’epiteto populista di solito equivale, se non ad un vero e
proprio insulto, certo ad una grave accusa: indica qualcosa a metà strada
tra la demagogia e l’intolleranza. Nell’accezione prevalente, il
populismo connota una posizione politica estremista, una forma di
regressione e di imbarbarimento del costume politico, una vera e propria
patologia politica: qualcosa, insomma, da censurare e da condannare.
Stando
ai suoi critici, esso esprime il lato oscuro ed irrazionale della politica,
quello nel quale prendono corpo i sentimenti peggiori e più inconfessabili
delle masse: da qui la sua assimilazione all’egoismo sociale,
all’aggressività, alla xenofobia ed al razzismo. Dal punto di vista
sociologico, il populismo viene abitualmente presentato come
l’espressione, in chiave di protesta politica, delle frustrazioni, delle
paure e dei risentimenti propri di determinate fasce sociali: quelle
culturalmente meno attrezzate e socialmente marginali, come tali più
facilmente inclini al qualunquismo ed all’uso di poche e rassicuranti
parole d’ordine. Dal punto di vista storico-culturale, invece, viene
dipinto come un fenomeno obiettivamente reazionario ed antimoderno:
l’espressione del disagio con cui taluni gruppi sociali vivono le
trasformazioni indotte da una modernità con la quale non riescono,
evidentemente, a sintonizzarsi. Dal punto di vista politico, infine, gli
vengono attribuite una visione complottista e cospiratoria della lotta
politica, una spasmodica ossessione per il nemico, un modo totalizzante e
romanticamente torbido di richiamarsi all’idea di popolo, una concezione
carismatico-plebiscitaria del potere e dei rapporti di obbligazione
politica: da qui la sua inclinazione verso l’autoritarismo e la sua
incompatibilità con le regole della democrazia rappresentativa.
Ciò
che prevale nel discorso politico pubblico è, dunque, una visione
assolutamente negativa, quasi caricaturale, del populismo, visto alla
stregua di una pericolosa sindrome politica o, nella migliore delle ipotesi,
come un segno di immaturità ed arretratezza. Ma si tratta di una visione
accettabile? Non esiste per caso un modo diverso di intendere questo
complesso fenomeno? Il populismo è realmente la negazione della democrazia
e della civiltà politica liberale o presenta anche un’altra faccia? Molti di coloro che si
sono occupati del populismo in sede di analisi scientifica convengono, in
effetti, nel definirlo una realtà bifronte, ambivalente e camaleontica,
tutt’altro che unitaria e come tale difficile da definire. Storicamente,
si sono avute forme talmente diverse di populismo da rendere quasi
impossibile l’individuazione di un tipo-ideale o l’elaborazione di una
tipologia che sia realmente esaustiva. Spesso esso ha assunto un volto
indubbiamente autoritario ed illiberale, ma altrettanto spesso si è
presentato sulla scena politica sotto una veste democratica e rispettosa del
pluralismo politico. Per descriverlo, dunque, non basta richiamare
l’immagine di masse popolari disperate e violente manipolate da leader
politici senza scrupoli; in certe sue incarnazioni storiche, infatti, il
populismo ha anche significato affermazione di una autentica sovranità
popolare, richiamo al “buon senso” dell’uomo comune contro
l’eccessiva intellettualizzazione dell’esistenza, rifiuto dello spirito
burocratico, del centralismo e di un’ingegneria sociale troppo spinta,
naturale diffidenza per un potere eccessivamente concentrato e per
oligarchie politico-economiche non solo molto distanti dal modo di vivere e
di pensare dei comuni cittadini, ma anche poco attente alle reali necessità
di questi ultimi.
Scopo
del presente dossier è proprio quello di mostrare come sia possibile
offrire del populismo una chiave di lettura molto diversa da quella
corrente, sia dal punto di vista storico (con riferimento dunque alle
molteplici e spesso contraddittorie forme che esso ha assunto nei più
diversi contesti nazionali) sia dal punto di vista politico (con riferimento
quindi al modo con cui il termine viene oggigiorno abitualmente utilizzato,
per indicare polemicamente alcuni dei movimenti e dei partiti emersi sulla
scena politica internazionale nel corso dell’ultimo quindicennio). Capire
cosa il populismo può essere realmente, di là da quelle interpretazioni
che tendono a presentarlo unicamente sotto una luce negativa, è importante
soprattutto nel caso dell’Italia, dove in anni recenti tutto un insieme di
avvenimenti e di personaggi – l’ondata giustizialista scatenata
dall’inchiesta Mani Pulite, la mobilitazione antipartitocratica ed
antipolitica di larghi settori dell’opinione pubblica, la fondazione di
Forza Italia ad opera di Silvio Berlusconi, la crescita delle leghe
autonomiste nel Nord Italia, l’ascesa politica di un personaggio come
Antonio Di Pietro, la nascita di un nuovo modo di fare informazione politica
in televisione, l’accresciuto utilizzo dello strumento dei referendum,
l’emergere di un ceto politico svincolato dai tradizionali canali di
selezione partitici – è stato visto come espressione, pur con differenti
modalità, di una ondata politica tipicamente populista; ondata che, a
giudizio di molti osservatori, ha investito l’Italia con una non casuale
coincidenza rispetto ad altri paesi occidentali, a dimostrazione di come il
crollo del muro di Berlino abbia segnato, con ogni probabilità, l’inizio
di un nuovo ciclo politico. In questi anni, nel nostro paese si è parlato
spesso di “deriva populista”, di “peronismo”, di
“telepopulismo”, dando per scontato che l’emergere ed il diffondersi
di istanze definibili populiste in senso lato – su tutte la richiesta di
un rapporto più diretto e simpatetico tra governati e governanti, resa
impellente dalla crisi dei soggetti politici protagonisti della cosiddetta
Prima Repubblica – abbia comunque rappresentato qualcosa di negativo se
non un vero e proprio rischio per la democrazia.
Contrariamente
a tale vulgata, ciò che si vuole mostrare in queste pagine è, per
cominciare, che non esiste alcuna correlazione automatica tra populismo ed
autoritarismo politico: al contrario, in certe sue espressioni il populismo
– inteso alla lettera come appello legittimante alla fonte della sovranità
politica, vale a dire al popolo considerato come una potenziale riserva di
virtù morali, di valori, di stili di vita e di norme di condotta – è
qualcosa di profondamente connesso con lo spirito e la prassi del governo
democratico. Non
solo, ma si vuole anche suggerire l’idea che nell’attuale fase storica
– segnata dalle profonde trasformazioni sociali politiche ed economiche
che si è soliti imputare ai processi di globalizzazione – istanze ed
ondate di populismo politico (con ciò che esse possono portare con sé,
magari confusamente, di passione, di entusiasmo, di coinvolgimento e di
impegno diretto e personale), lungi dal rappresentare un pericolo per la
democrazia, possono invece costituire addirittura una risorsa, un momento di
ricarica, una scossa energetica per ordinamenti politici (come è ad esempio
quello italiano) in crisi crescente di rappresentatività ed ormai sempre più
incapaci di suscitare la benché minima passione o emozione, sempre più
percepiti come freddi e distanti rispetto alla vita reale delle persone,
visti unicamente come erogatori di (peraltro spesso scadenti) servizi e non
anche come aggregati di valori sociali condivisi; ordinamenti nei quali –
come mostrano numerose rilevazioni statistiche – vanno crescendo non a
caso la sfiducia nei confronti dei governanti, l’apatia politica, il
numero dei cittadini che non si sentono adeguatamente rappresentati e quello
di coloro che non votano più alle consultazioni politiche, il divario (non
solo politico, ma anche di stile di vita, di linguaggio e di sensibilità)
tra la gran massa dei cittadini e le cosiddette classi dirigenti. Il
populismo odierno costituisce, a ben vedere, una reazione a tutto ciò, ad
una democrazia le cui basi psicologiche, culturali e spirituali si vanno
facendo assai fragili, al punto da pregiudicare anche la solidità delle sue
architetture istituzionali.
Prendendo
lo spunto dai molteplici cambiamenti che nel corso degli ultimi tempi si
sono verificati sulla scena politica italiana ed internazionale, si è
quindi cercato di capire se l’ascesa di leader e movimenti che a diverso
titolo sono stati etichetti come populisti rappresenta – come spesso
banalmente si sostiene – una nuova forma di irrazionalismo politico o
peggio la minaccia (sotto mentite spoglie) di un nuovo fascismo, o non stia
piuttosto ad indicare la pressante richiesta di un modo nuovo di fare
politica a fronte, da un lato, della obiettiva involuzione in senso
oligarchico-burocratico dei regimi politici democratico-rappresentativi
contemporanei, e dall’altro, del vero e proprio deficit di legittimità
democratica di cui soffrono molti degli organismi, delle istituzioni e delle
organizzazioni che, a livello sovranazionale, ormai orientano e gestiscono
la vita di buona parte dell’umanità, nei confronti dei quali non a caso
va montando, a livello popolare, un misto di avversione e di diffidenza. Si
pensi, tanto per fare un esempio, all’ostilità, comune a molti movimenti
populisti odierni, nei confronti dell’Unione europea,
percepita da questi ultimi come un costrutto burocratico oppressivo e
senz’anima, unicamente come uno strumento di pianificazione sociale e di
regolamentazione economico-giuridica, del tutto autoreferenziale e privo di
una autentica radice democratica e popolare.
Il
populismo, sostiene chi lo ha studiato, non è una ideologia o un programma
politico. Non presenta cioè un profilo organicamente strutturato. E’
piuttosto uno stile argomentativo, una retorica, una modalità del discorso
politico. Ciò che lo caratterizza, in generale, è il suo eclettismo
ideologico, la sua dimensione
interclassista, il suo oscillare tra destra e sinistra, la sua natura
reattiva e protestataria, il suo presentarsi sulla scena nei momenti di
crisi. Date tali caratteristiche, il populismo non può rappresentare, si
sostiene, una soluzione politicamente efficace. Esso è tuttavia
efficacissimo, crediamo, come indicatore del disagio, come termometro con il
quale misurare la temperatura del corpo sociale nelle fasi di più rapido e
traumatico cambiamento. Per quanto riguarda la rinascita del populismo nel
contesto attuale, dopo il crollo del comunismo e l’apertura di una fase
dominata dalla unipotenza americana, concordiamo con chi, come Ludovico
Incisa di Camerana, ha sostenuto qualche tempo fa che essa deve essere vista
«come una forma di resistenza alle istanze più radicali del
neoliberalismo, alla negazione dello Stato nazionale, alla generalizzazione
dello spirito di competizione, all’omologazione economica ed informativa,
agli stereotipi introdotti dalla rivoluzione delle telecomunicazioni». Il
fatto che il populismo spesso articoli pubblicamente le proprie ragioni con
un linguaggio rude e folcloristico, poco aderente in effetti al palato dei
politologi e dei commentatori politici, non può farci trascurare le
complesse questioni che la sua sola presenza sulla scena politica
contribuisce a sollevare a proposito, ad esempio, del modo con cui la
politica subisce oggi l’invadenza dell’economia o di come effettivamente
funzionano le democrazie.
Gli
interventi che seguono offrono del populismo una chiave di lettura, certo
problematica, ma anche, come già accennato, piuttosto diversa da quella
corrente e a nostro giudizio più adeguata per comprendere quanto sta
accadendo sotto i nostri occhi. Lo scritto di Paolo Pombeni – che
circoscrive la sua analisi al contesto europeo occidentale – ha un taglio
rigorosamente storico e mostra come le radici del populismo (del quale
suggerisce una originale tipologia) siano strettamente intrecciate con
quelle dei sistemi costituzionali fondati sul principio di rappresentanza;
nei confronti di questi ultimi il populismo si presenta, spiega lo studioso
dell’Università di Bologna, come «quella ideologia che propone di far
risiedere la legittimazione politica nella esistenza di una “consonanza”
fra le sedi del potere politico ed il “popolo”, che viene
programmaticamente considerato come un qualcosa di diverso dalle istituzioni
che raccolgono e rappresentano il consenso delle componenti politiche».
L’articolo
di Paul Piccone costituisce un’appassionata difesa del “populismo
democratico”, una tradizione peculiare della storia politica americana a
cavallo tra il XIX ed il XX secolo – un misto di democrazia diretta,
localismo, difesa della piccola proprietà e rifiuto del centralismo – che
il direttore della rivista Telos ha avuto il merito di rilanciare in una
chiave, come egli la definisce, postliberale e postmoderna, neofederalista e
neocomunitarista, e in forte polemica con la New Class politico-manageriale
che ormai governa la politica statunitense. Chi,
in anni recenti, più di altri ha tematizzato il nesso “virtuoso” tra
populismo e democrazia, richiamando l’attenzione su ciò che,
parafrasando Ortega y Gasset, ha definito la “ribellione delle élites”,
vale a dire il crescente distacco, comune a molti paesi occidentali, dello
stile di vita e della mentalità delle classi alte rispetto al resto della
popolazione, è stato lo storico statunitense Christopher Lasch, che
rappresenta non a caso una delle fonti ispiratrici di Piccone. Proprio a
Lasch – indimenticato autore di un piccolo classico del pensiero sociale
contemporaneo quale La cultura del narcisismo, ma ancora non particolarmente
apprezzato in Italia nella sua veste di storico e teorico del populismo –
è dedicata la nota di Consuelo Angiò. Al
populismo visto come fonte di democrazia, come legittima reazione contro lo
statalismo centralizzatore e contro l’onnipotenza dei tecnocrati che
governano gli Stati sociali contemporanei, è dedicato l’intervento di
Alain de Benoist, fautore – anch’egli sulla scia di Lasch – di un
modello di democrazia diretta e partecipativa e di forme di cittadinanza
attiva su base comunitaria.
Ludovico
Incisa di Camerana è da lunghi anni uno studioso attento del populismo, con
particolare attenzione per quello latino-americano (sul tema del
“populismo autoritario” e del “nazional-populismo” ha scritto
importanti studi a firma Ludovico Garruccio, il suo storico nome de plume).
Nel suo contributo, egli affianca provocatoriamente alla “terza via”
socialdemocratica, oggi tanto in voga, una problematica ma non del tutto
irreale “quarta via” populista, alimentata dall’opposizione che anche
all’interno del mondo sviluppato occidentale va crescendo nei confronti
della globalizzazione e dei suoi effetti. Il
testo di Eugenia Roccella cala le sue riflessioni nel contesto della lotta
politica italiana, mostrando quanti diversi volti il populismo possa in
realtà assumere: quello giustizialista e demagogico di Di Pietro, quello
seduttivo e liberale di Berlusconi, quello opportunistico del “partito dei
sindaci”. Ad
alcune tra le più vistose espressioni del populismo politico contemporaneo
– a partire da quella, assai controversa, incarnatasi nel partito
liberal-nazionale austriaco di Jörg Haider – è invece dedicato il
reportage di Pierluigi Mennitti, che mostra ancora una volta come tale
fenomeno, diffusosi ormai su una scala europea, vada, più che esorcizzato o
brandito polemicamente, compreso nelle sue reali scaturigini e nel suo più
profondo significato politico. Per
concludere, una chicca, offerta anch’essa dalla Angiò: quanti, tra coloro
che hanno letto ed amato Il Mago di Oz, sapevano che il capolavoro
pubblicato esattamente un secolo fa, nel 1900, da L. Frank Baum, è in realtà
un apologo populista e che dietro le avventure della piccola Dorothy, dello
Spaventapasseri, del Boscaiolo di Stagno e del Leone Codardo si nascondono
l’insofferenza verso il potere, il rispetto di sé, il buon senso, lo
spirito di autonomia, l’amore per la propria terra, l’etica del lavoro,
la difesa della piccola proprietà, il senso comunitario ed il parlare
semplice e chiaro così tipici della tradizione del populismo democratico?
(Ideazione Marzo-Aprile 2000)
|
|