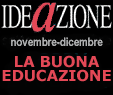Rileggere il
craxismo
UN'OMBRA INQUIETANTE
PER LA SINISTRA
di Giovanni
Tassani
Il
4 maggio 1977 il segretario del Partito socialista italiano Bettino Craxi
svolge una relazione sul tema “Marxismo e revisionismo” alla Karl Marx
Haus di Treviri, città natale di Marx, per conto della Fondazione Friedrich
Ebert, avendo a fianco il presidente dell’Internazionale socialista Willy
Brandt. Rileggendo oggi quella relazione, che precede di oltre un anno il
celebre “Vangelo socialista” – l’articolo di Craxi su Proudhon
– che avrebbe bruciato le polveri della polemica politica Psi-Pci,
possiamo ben vedere il segno deciso di un riformatore della sinistra
italiana: un Craxi non polemico ma analitico rivendica la superiorità
d’una lettura che colleghi la prudenza del Capitale, l’ultimo Engels, il
gradualismo di Kautsky e Bernstein, la lezione italiana di Rodolfo Mondolfo
e Critica Sociale, rispetto all’utopismo quarantottesco del Manifesto,
della Comune, del bolscevismo di Lenin e Trotzky e della loro idealizzazione
in Gramsci. Conservare memoria di Marx significa per Craxi consegnarlo alla
storia, non imbalsamandolo ma sviluppandone criticamente l’esigenza,
teorica e pratica, di democrazia socialista. Il segretario d’un partito
entrato da appena un decennio nell’Internazionale è ora pienamente
accreditato a parlare nel quadro d’un progetto in formazione,
l’eurosocialismo, che sarà messo a fuoco a Bruxelles l’anno seguente,
in vista delle prime elezioni dirette dell’Europarlamento, nel 1979.
Un’alternativa
politica di sinistra, un’alternativa modernizzante nella sinistra: questo
il punto di partenza del politico Craxi, giunto alla segreteria nel luglio
1976, a capo d’una corrente del 10 per cento, in un partito che ha
registrato neppur un mese prima appena il 9,6 per cento alle elezioni più
contrappositive – in nome dell’ipotizzato “sorpasso” Pci sulla Dc
– dal 1953. “Revisionismo” e “riformismo” sono parole chiave,
spregiate dalla sinistra in voga a quell’epoca, e connotate invece da
Craxi di significato positivo. Esse diverranno sfida e bandiera. Craxi
capisce bene che nel Pci berlingueriano è partito un ampio processo di
revisione e adeguamento, ma conoscendo bene tempi e modi del proprio
competitore a sinistra, decide di lavorare in anticipo sui limiti del Pci. E
questi sono soprattutto due, tra loro interconnessi: il legame residuo ma
tenace con l’Unione Sovietica, la concezione “egemonica”, vero
archetipo profondo del personale politico comunista, e non pienamente
pluralistica, del rapporto politica-società, che all’epoca impedisce al
Pci di poter parlare positivamente di “alternanza” democratica nel
sistema politico.
Se
non ci si vuol rinchiudere in una visione grettamente politicista delle
cose, per cui tutte le questioni teoriche e storiche sollevate in anni di
convegni di Mondoperaio avrebbero in realtà celato soltanto una volontà di
delegittimare il Pci precludendogli la condivisione del potere, si deve
ammettere che la campagna di revisione ideologica, da Craxi principalmente
voluta, ha giocato, per la sinistra e all’interno di essa, un ruolo
positivo, di crescita. Provocazione sì, ma nutrita di contenuti e di
anticipazioni culturali oggi divenuti patrimonio comune: basti pensare a
Popper e a Bobbio, all’origine dei dibattiti socialisti. Un primo
riconoscimento pare debba dunque esser tributato al Craxi delle origini:
quello di aver animato una stagione viva e scintillante, forse l’ultima in
Italia, di ampio dibattito politico-culturale. Per capir questo occorre
capire il personaggio: lottatore tutto-politico, sul piano cioè degli spazi
di potere, ma contemporaneamente sul piano della prospettiva culturale. E
non si capisce una dimensione senza l’altra. La formazione di Craxi, nella
Milano della collaborazione amministrativa socialista-democristiana, s’era
tatticamente arricchita d’una esperienza negli organismi universitari
nazionali e sprovincializzata grazie agli incarichi ricevuti dal partito in
campo estero. Come per Berlinguer anche per Craxi per esempio il Cile
diventerà un paradigma politico, seppur diversamente interpretato nelle
conseguenze: monito a non perdersi in estremismi e fughe dalla realtà
mentre si deve saper governare. Non sessantottino, occidentalista convinto,
Craxi può cominciare a sfidare i miti che avevano premiato il Pci
facendogli intercettare, tra amministrative ’75 e politiche ’76, gran
parte del voto giovanile (fascia 18-21 anni) al suo debutto:
anticapitalismo, operaismo e terzomondismo. Quello di Berlinguer è un
realismo diverso: esso, in attesa della fuoruscita dal capitalismo, si fa
carico di un disormeggio graduale da un’ampia storia, di cui il tentativo
“eurocomunista”, di pur necessario collegamento con francesi e spagnoli,
con le timide critiche ai “tratti illiberali” dei regimi dell’Est, fa
oggi capire inadeguatezza di prospettiva, se non tragicità.
E’
invece un’altra tragicità a dare spinta a Craxi: il “caso Moro”, in
cui egli decide di porre il suo partito al centro d’una vasta opinione
pubblica trasversale che comprende settori libertari e di neo-sinistra,
parti delle istituzioni, del Vaticano e della stessa Dc. Di fronte a un Pci
rattrappito nella fermezza, Craxi mostra l’elasticità necessaria a una
possibile trattativa che miri, sia pur con rischi e pericoli, a un obiettivo
etico oltre la ragion di Stato. Craxi capisce che, per dirla con l’ultimo
Moro, l’Italia s’è già “rimescolata” e sempre più cambierà,
anche nelle proprie appartenenze come nelle opinioni politiche. Estraneo al
composto Dc, auspica che, come in Francia e altrove in Europa, i cattolici
escano da quella gabbia neutralizzante per una scelta libera e autonoma, e
afferma in positivo la conciliazione tra gli ideali del socialismo e i princìpi
del cristianesimo: anche qui battendo in breccia una vecchia concezione di
laicità mantenuta, al di là di ogni pratica diplomatica e attitudine
mediatoria, dal Pci.
E’
stato deriso e deformato il richiamo in Craxi a Proudhon e poi a Garibaldi:
ma anche in questo campo il richiamo era ad un socialismo di popolo che
incontrasse le radici nazionali, senza giacobinismi e aristocrazia
intellettuale. Questo il Craxi combattente cultural-politico, che conosce
bene la storia del socialismo e della nazione: anticipatore, modernizzatore
nel campo delle idee, che pianta nel gran vento di sinistra degli anni
Settanta una bandiera-paletto sul terreno dei princìpi di socialismo e
libertà.Il Craxi combattente tutto-politico compirà altre battaglie di
modernizzazione, necessarie allo sviluppo del paese ma non altrettanto
innovative nella prassi e nel costume politico. Innovativo quanto a finalità
giustamente intuite, ma spesso impreciso nella progettualità, troppo
disinvolto nell’uso dei mezzi, fallirà l’obiettivo nel corso d’un
trend a lui sì favorevole in termini statistici (l’onda lunga tanto
invocata e giunta al massimo del 15,3 per cento alle regionali del ’90, a
neppur 10 punti di distanza dal Pci), ma che lo isolerà e lo renderà
distante dal sentire comune sempre più in congedo libero dai partiti, anche
se non dalla voglia di cambiare. Funzionerà solo per alcuni anni l’intesa
Craxi-Pannella, non potrà funzionare un’intesa, che non ci sarà,
Craxi-Segni.
Dopo
lo scandalo Eni-Petronim, origine della liquidazione del leader della
sinistra socialista Claudio Signorile e del passaggio con Craxi di Gianni De
Michelis, e la decisione circa l’installazione dei missili Nato, alla cui
origine era stata la preoccupazione espressa dall’ex cancelliere
socialdemocratico tedesco Helmut Schmidt verso il riarmo all’Est, sono
maturi i tempi per la partecipazione diretta del Psi , dopo oltre cinque
anni, ad un nuovo centro-sinistra con la Dc e il Pri nel governo Cossiga 2,
non senza aver prima saggiato la candidatura dello stesso Craxi, tra i
designati da Pertini a guidare l’esecutivo. La Dc post-zaccagniniana del
“preambolo Donat Cattin” aveva deciso qualche mese prima il no secco a
un Pci che, per parte sua, con la nuova svolta di Salerno aveva scelto
un’opposizione “etica” di sistema, rivendicando l’“alternativa
democratica”, opponendosi all’entrata dell’Italia nel Sistema
monetario europeo (Sme), cavalcando il nascente movimento pacifista.
Può
esser definita quella di Craxi una correzione strategica, incoerente con la
posizione alternativista precedente? Non credo lo si possa affermare, se si
mantiene l’ottica in una prospettiva europea e l’attenzione al tema
della governabilità italiana in anni in cui il terrorismo ancora devastava
quasi quotidianamente il tessuto nazionale. I toni craxiani non si smorzano
e la battaglia viene da lui aperta su più fronti. La Grande Riforma
istituzionale, evocata ma non meglio precisata oltre all’elezione diretta
del presidente della Repubblica e la soglia minima per l’elezione in
Parlamento, fa parlare di bonapartismo, o peggio, ad una sinistra paga del
proporzionalismo vigente.Il decisionismo di Craxi si rivela ben più duro
all’interno del Psi ove ad uno ad uno gli avversari vengono fermati nei
sogni d’ascesa (Giolitti), esautorati nel disegno politico-culturale
(l’intero gruppo di Mondoperaio) e addirittura espulsi (Codignola,
Enriquez Agnoletti, Bassanini, Ballardini). sIn diversi daranno lustro alle
liste Pci nelle successive elezioni. Nonostante i conflitti e le perdite il
Psi può nell’estate ’82 celebrare con successo a Rimini una conferenza
programmatica che prelude nei temi trattati alla politica governante del
Craxi ’83-87: crescita del potere decisionale dell’esecutivo, riduzione
degli oneri pubblici del welfare state in termini di bilancio e spesa
pubblica, coniugazione di giustizia ed efficienza (“meriti e bisogni”
per il vicesegretario unico Claudio Martelli per il quale socialismo è una
forma di individualismo mitigato). A Palermo l’anno prima il Psi nel suo
congresso aveva “celebrato” con elezione plebiscitaria il leader,
riaffermato l’orgoglio “riformista” e umiliato le ormai residue
opposizioni interne. Verona ’84 e Rimini ’87 accentueranno il carattere
spettacolare, e quasi oracolare, del messaggio coltivato dalla leadership,
ossia dal leader. Tra le due date si esprime il Craxi governante con due
ministeri di durata complessiva inferiore solo a quelli di De Gasperi e, di
poco, di Moro.
Gli
atti fondamentali dei governi Craxi sono legati come si sa alla firma del
nuovo Concordato con la Santa Sede nell’84, al taglio dei punti di
contingenza che conduce al referendum del giugno ’85 – e in cui Craxi ha
dalla sua la Cisl di Carniti, la Uil di Benvenuto, parte della Cgil e
studiosi pur vicini più al Pci che al Psi come Tarantelli – alla
disciplina dell’emittenza televisiva – pur ricorrendo anche qui
all’abusata decretazione d’urgenza: cosiddetto decreto Berlusconi bis,
gennaio-febbraio ’85 –, alla coerenza nella questione
dell’installazione dei missili Pershing e Cruise. Ma un altro atto, benché
postdatato ’88, è ascrivibile come successo politico a Bettino Craxi: la
drastica riduzione dell’uso parlamentare del voto segreto, fonte di
manovre e agguati di “franchi tiratori” nonché di prassi negoziali
sotterranee da “governo ai margini”. Il segno della decisione craxiana
è connesso anche al no al nucleare ribadito coi referendum dell’8
novembre ’87, ove è votata anche la responsabilità civile del giudice,
il che non impedisce successivamente il netto distinguo dai radicali circa
il permissivismo in tema di droghe. Tutto ciò contribuisce sicuramente a
designare Craxi come la personalità politica italiana più rilevante dal
dopo-Moro a tutti gli anni Ottanta, al punto che al di là dello sfondo
(Pertini, Berlinguer) le altre figure che han lasciato traccia di sé,
Spadolini, De Mita, posson essere definite, sia pur in modo diverso, figure
di contrasto a Craxi.
Certamente
l’ultima fase craxiana (’87-92) fa emergere, dilatandoli, tutti i limiti
insiti nella strategia del leader socialista, che saranno poi la causa della
sua fine politica. Il partito è stato crescentemente trasformato in
palestra d’ascesa e soddisfazione d’un ceto espansivo-assessorile
dimentico di regole, e congressualmente in un’arena plaudente senza più
comitato centrale e neppure esecutivo, gonfio solo d’una pletorica, neppur
eletta, assemblea nazionale di 600 membri. Craxi ha battuto alla lunga la Dc
resistendo alla sua pretesa di coerenza nelle giunte locali, ove ha attuato
il principio non scritto dell’“ovunque in maggioranza, con chiunque,
alzando il prezzo”: ma in base allo stesso principio nasceranno allora
centinaia di giunte Dc-Pci. La sua ricerca spregiudicata di attrarre a sé
alcuni poteri forti rimarrà a metà. E tanto più il Psi si autocentrava
sulla corsa all’espansione del proprio potere, più scemava la capacità
potenzialmente federativa di un’area liberaldemocratico-socialista più
ampia. L’alternanza si allontanerà e Craxi, dopo il fallimento della
commissione Bozzi, si divincolerà a fatica dal legame con Forlani e
Andreotti tesi a fargli sottoscrivere un’alleanza stabile con la Dc con
premio di maggioranza elettorale. Federalismo “padano” e movimento
referendario, quali segni di intolleranza sempre più diffusa alla
“partitocrazia” faranno il resto. La figura di Craxi è oggi già
consegnabile, con il rilievo che le spetta, alla storia d’una stagione
irrimediabilmente trascorsa del paese. E alla storia soprattutto d’una
sinistra che non può permettersi di rimuovere senso e complessità d’una
comunque “istruttiva” lezione.
(Ideazione Gennaio-Febbraio 2000)
|
|