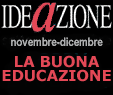Congetture
& confutazioni
A SEATTLE,
TRA STATI E SOCIETA'
di Giuseppe
Sacco
Che l’ambigua rivolta di Seattle abbia segnato un punto di svolta destinato
a pesare assai a lungo sull’evoluzione dell’ordine mondiale, è stato
rilevato con sconcerto da tutti gli osservatori. Un decennio caratterizzato
dall’abbattimento delle frontiere e dalla perdita di potere degli Stati
nazionali è parso chiudersi con una brusca battuta d’arresto, con un revival
delle aspirazioni alla sovranità dei singoli Stati. Un’altra lettura degli
eventi sembra invece possibile. Il decennio si è aperto con il fatidico
1989, bicentenario della Rivoluzione francese e funerale di quella russa, e
con il crollo della Germania comunista: un accadimento altamente simbolico
del riemergere della società nazionale rispetto alle costruzioni statuali. I
fattori politici e di potere, che per quarant’anni avevano tenuto in vita
due Stati tedeschi, non sono stati più capaci di reggere contro il
sentimento collettivo di un popolo. La società tedesca ha riaffermato in
maniera prepotente la propria identità ed imposto la riunificazione,
spazzando via la divisione postbellica, le esitazioni dell’Eliseo, l’aperta
ostilità di Downing Street. Profondamente feriti, gli Stati hanno, dopo di
allora, moltiplicato i Trattati, per creare o rafforzare organizzazioni
internazionali destinate – nei loro disegni – a controllare e incanalare il
processo dirompente attraverso il quale le società si modernizzano, si
aprono alla rivoluzione delle telecomunicazioni, si avvicinano e si
mescolano.
Lo
stesso Wto, che si presenta come lo strumento della globalizzazione, è in
fondo un tentativo delle burocrazie tecnico-diplomatiche di addomesticare
questo fenomeno. Con la sua regola della decisione per consenso, è il
tentativo degli Stati tradizionali di patteggiare tra loro le norme che
dovranno regolare la nuova società globale. Il tentativo più visibile, ma
non il solo: basta guardare all’Osce, e alla sua patetica ambizione di
ingessare nei Balcani un soffocante mosaico etnico, ereditato dall’Impero
ottomano, e come quello incompatibile con il mondo contemporaneo. È questo
tentativo che è stato sfidato e sconfitto a Seattle, dove la società civile
si è riappropriata della questione del sistema mondiale, non solo
relativamente alle specializzazioni ed agli scambi, ma in tutte le
implicazioni culturali, identitarie e politiche che sono connesse al
processo di globalizzazione. Ed ha mostrato di volerne gestire
l’organizzazione a modo suo, con priorità, parametri e criteri di
valutazione diversi da quelli dei governi e dalle tecnocrazie. Diciamo
subito che la variopinta folla che nelle strade di questa città portuale del
Pacifico ha dato scacco ai governi costituisce solo un piccolo, e neanche
rappresentativo, frammento della società globale. L’ambiguità
dell’insurrezione di Seattle sta proprio in questo: nel fatto che i poveri
del mondo erano assenti. Anzi, la rivolta era diretta anche contro i più
poveri del mondo, e contro l’aspetto più positivo del processo di
globalizzazione: quello che, negli ultimi vent’anni, ha permesso di far
entrare nel mercato del lavoro quasi due miliardi di uomini che languivano
inoccupati ai limiti della morte per fame.
Per non parlare di almeno altri due miliardi di esseri umani, che dai
benefìci della globalizzazione non sono stati ancora neanche sfiorati. Per i
“dannati della terra”, con i salari tra 3 e 7 dollari al giorno offerti
dalle aziende che hanno investito nel Terzo Mondo, la globalizzazione ha
aperto un’era di lavoro e di benessere che sino a ieri non era neanche
possibile sognare. Ma ha anche creato una situazione che li vede in
concorrenza con i lavoratori dei paesi ricchi, abituati a guadagnare – per
lo stesso lavoro – una media di 25 dollari l’ora. Ed erano questi ultimi a
scagliar sassi nelle strade o a sfondare le vetrine dei negozi, e i loro
figli, che dovranno ormai accontentarsi di lavoretti nel settore dei servizi
per 7 dollari l’ora, cioè solo dieci o venti volte di più degli operai dei
paesi poveri. Lo sconcerto creato dal fallimento della Conferenza del Wto
deriva da questo carattere di minoranza privilegiata, e timorosa di perdere
tali privilegi, di coloro che si sono fatti interpreti della protesta.
Deriva dal fatto che la rivendicazione di un governo meno burocratico del
processo di globalizzazione è stata condotta da un frammento della società
dominante, e non dalle nazioni subalterne, ancora escluse dal trasferimento
di capitali e tecnologie. Queste ultime, si noti, partecipano anch’esse alla
generale apertura della società mondiale. Solo che vi partecipano
affidandosi agli scafisti albanesi come immigrati clandestini, affollando le
chiese francesi in cui si rifugiano i sans papiers, o attraversando di notte
il confine tra Messico e Stati Uniti. La loro voce, al Wto come nelle strade
di Seattle, era assente. Ma la loro pressione è avvertita in tutte le
società avanzate, e contribuisce a creare – a livello mondiale – una forte
domanda di riappropriazione sociale del processo di globalizzazione. Questa
ambigua protesta, che esprime però un’esigenza reale, non basterà – se ne
sia certi – a spezzare la dinamica della mondializzazione, che discende da
fattori incoercibili come il tumultuoso progresso tecnico-scientifico e
l’azzeramento delle distanze, soprattutto di quelle psicologiche. Ad essere
sconfitto a Seattle è stata non la globalizzazione, ma il Wto, cioè l’idea
che si possa costruire il governo mondiale fuori da ogni controllo della
società, con una piramide di Stati organizzata per gerarchia di potenza.
La
globalizzazione, per il futuro prevedibile, sembra destinata a proseguire,
come processo di crescita integrata delle diverse economie, di mescolamento
delle culture, e persino delle razze. Ma si innesterà su due fenomeni ormai
evidenti: la continuazione della decadenza degli Stati a vantaggio della
società e il manifestarsi, dopo un decennio in cui della globalizzazione
sono stati risultati prevalenti i benefìci economici, di alcuni costi,
sinora sottostimati e talora insospettati, di tale processo. Perché i costi,
gli aspetti negativi, sono innegabili. E se la globalizzazione ha potuto
sinora convivere con le tendenze dirigistiche delle burocrazie nazionali, e
col loro tentativo di dominare il processo attraverso gli organismi
intergovernativi, è solo perché si è trattato della fase “facile”
dell’apertura delle società e dei mercati. Quella che inizia ora è però una
fase più complessa, in cui i problemi da affrontare sono troppo seri perché
sia possibile affidarli a burocrati, diplomatici e funzionari
internazionali. Tale fase potrà essere gestita solo dalle società civili,
attraverso strumenti ancora in larga parte da inventare, ma che – è facile
previsione – comporteranno profonde trasformazioni nei modi di governare la
vita associata, nei criteri di aggregazione dei gruppi sociali, e persino
nelle caratteristiche in base alle quali siamo abituati a percepire la
nostra stessa identità.
(Ideazione Gennaio-Febbraio 2000)
|
|