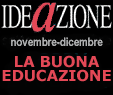Feuilleton
INTELLETTUALI?
NO, IRREGOLARI
di Eugenia
Roccella
Il
conto alla rovescia è finito, il nuovo secolo, e il nuovo millennio, sono
ormai semplicemente il nostro presente. Non sentiremo più, per fortuna,
l’abusata dizione “fine millennio”, non assisteremo più a frettolosi
tentativi editoriali di compilare bilanci, classifiche, valutazioni,
emettere giudizi e definizioni, tirare conclusioni sul Novecento. Emana però
dal secolo concluso la suggestione di un passato che ci appartiene
pienamente (anzi: “che non passa”) e che pure è già inghiottito
dall’ombra di una modernità separata dall’oggi, di cui possiamo
occuparci con i criteri che sovrintendono alla storia e alla memoria.
Ma si
può trattare la contemporaneità come storia, evitando i rischi connessi
sia alle semplificazioni e alle forzature interpretative di “fine
secolo”, sia a quelle dovute alla peculiarità italiana, per cui il
Novecento continua ad essere fonte di legittimazioni e delegittimazioni,
campo aperto di lotta politica e scontro ideologico? L’ultimo volume della
Storia d’Italia curata da Vittorio Vidotto e Giovanni Sabbatucci per
Laterza, ci sembra, in questo senso, un tentativo riuscito; un utile
strumento di riflessione in cui convivono in equilibrio la ricca offerta di
dati, e ipotesi critiche circostanziate. Nel saggio d’apertura Vittorio
Vidotto dà conto, con ampia documentazione, dei grandi mutamenti sociali
intervenuti a partire dagli anni ’60, dalla profonda trasformazione del
ruolo femminile, e quindi del modello familiare, all’equilibrio città-campagna;
dalla crescita dei ceti medi, alla moltiplicazione e stratificazione di
consumi e stili di vita. E propone come categoria interpretativa della
società italiana di quegli anni, la conflittualità: una conflittualità
continuata, generalizzata e radicale che rappresenta un unicum nella
geografia occidentale. «Nessun paese europeo conobbe una stagione così
insistita e prolungata di conflitti sindacali e non, una così ricca varietà
di forme e di livelli di protesta. Nessun paese europeo conobbe un
terrorismo politico, di destra e di sinistra, attivo per un periodo così
lungo e con un costo di vite umane così elevato. Solo l’Italia conobbe
un’area così ampia di indulgenza per le forme di violenza sovversiva e un
così lungo consenso, o tolleranza di fatto, per il terrorismo di
sinistra...».
Ma
questo perenne conflitto corrispondeva effettivamente a gravi tensioni
sociali, o fu soltanto “la drammatica messa in scena della
rappresentazione di un conflitto ideologico”? Vidotto propende per la
seconda ipotesi, ed è interessante la scelta lessicale che indica
sottilmente, come carattere essenziale di quel conflitto, l’elemento del
palcoscenico: la messa in scena e la rappresentazione. Insomma, forzando la
prudenza dello storico, potremmo vedere l’ideologia come canovaccio di
azione scenica, living theater; e le piazze d’Italia elette a scenografico
sfondo per questa guerra simulata che, come nel miglior teatro nel teatro,
ha finito col produrre morti e lutti veri, tragedie fin troppo reali. Alla
luce di questo eccesso di ideologia, che antimarxianamente produceva vero
scontro sociale, diventa centrale il saggio di Pierluigi Battista, appunto
su Cultura e ideologie. Siamo nel cuore di quello che i curatori
definiscono, nell’introduzione, “sovrainvestimento ideologico”; sulla
mappa ben disegnata dei gruppi, delle tendenze, dei conflitti e delle
polemiche, si allunga l’ombra dell’egemonia culturale della sinistra.
La
ricostruzione di Battista si apre con un titolo simbolo di quegli anni,
Apocalittici e integrati, che segnava il passaggio dell’Italia alla
cultura di massa, con tutte le sue conseguenze positive: nuove frizzanti
curiosità, libertà immaginativa e creativa, accesso generalizzato alla
cultura. Ma anche con la cancellazione dell’Italia provinciale di
Guareschi, la destabilizzazione di un “ceto dei colti” chiuso ma di
grande livello, il declino della tradizione umanistica. A reagire con un
secco rifiuto davanti a questi fenomeni, che immettevano nella postmodernità
un paese che non aveva mai veramente digerito il moderno, furono prima di
tutto i cattolici e chi si sentiva a suo agio nel carattere elitario della
cultura italiana, come il raffinato gruppo del Mondo. Questo rifiuto, nota
l’autore, testimoniava una debolezza intrinseca della borghesia colta
italiana, che si sentiva minacciata anziché rafforzata da una crescita dei
ceti medi e da una democratizzazione del sapere.
Ma
dopo la prima ondata di entusiasmi, anche l’atteggiamento della sinistra
cominciò lentamente a cambiare. Fu Pasolini, vero profeta di quell’epoca,
a dare voce e concetti al disagio che serpeggiava anche tra chi aveva
accolto i nuovi fenomeni con innocente euforia. L’establishment culturale
della sinistra, che fino ad allora aveva coniugato la propria tradizione di
pensiero con tutto il nuovo che premeva alle porte, cominciò a vedere le
crepe prodotte nell’assetto “totalizzante” necessario a qualunque
vulgata marxista. La complessità, fattore ineliminabile della nuova società,
scardinava velocemente le rassicuranti strutture interpretative di un tempo;
le care, vecchie classi sociali annegavano in un variegato ceto medio,
sommergendo anche l’antropologia dell’Italia delle lucciole.
Da
questo momento si spegne, con una lunga agonia, la gloriosa sensazione della
sinistra di essere comunque dalla parte del futuro, di appartenere a una
storia di speranza e di progresso. Ma se lo slancio vitale va
affievolendosi, restano pur sempre le solide ragioni di un potere culturale
ormai affermato, ramificato, ben inserito in tutti gli snodi essenziali
della comunicazione. La sinistra rispolvera dunque la vetusta categoria
dell’impegno, con cui si isolano gli intellettuali meno disposti ad
integrarsi in logiche di gruppo e di appartenenza. Battista ricorda il caso
di Goffredo Parise e il suo elogio del disimpegno, o la sempre più acuta
insofferenza di Montale, chiuso in una nobile marginalità. Ma è su
Leonardo Sciascia che la dittatura dell’engagement si incarta e si
contraddice, mettendo definitivamente in chiaro che per impegno ha da
intendersi una precisa, e ben collocata, connivenza-convivenza, e non
soltanto una partecipazione “esemplare” dell’intellettuale alla vita
civile. Sciascia è, in Italia, forse l’esempio più classico di scrittore
impegnato, che però vive la sua scelta come dovere morale e intellettuale
non riconducibile ad altro che alla propria coscienza. Le posizioni prese
sul caso Moro, e ancor più quelle successive sull’antimafia, danno luogo
a un attacco concentrico di aspra violenza, che isola lo scrittore, ma segna
anche la fine di ogni teorizzazione del ruolo sociale dell’intellettuale.
Altrettanto
violento è l’attacco allo storico Renzo De Felice, soprattutto in seguito
alla pubblicazione della sua Intervista sul fascismo, nel 1975. Si tratta di
difendere le antiche frontiere su cui si basano l’accordo tra le forze
politiche italiane del dopoguerra e il “mito di fondazione”
resistenziale, attraverso una versione militante (impegnata?) del compito
dello storico. Ma soprattutto di imporre una visione ontologica del fascismo
come male assoluto, prefigurando un nemico eterno, una sorta di inconscio
repulsivo che giace nel fondo della storia e lì va lasciato, badando che
non torni mai a galla. È evidente che questo costituisce una
delegittimazione non storica ma teorica della destra (di qualunque destra)
che per quanto rinnovata o ripulita ha alle spalle un fantasma
inaccettabile. E costituisce il motivo di quella permanente suscettibilità
dell’area di sinistra di fronte alle revisioni storiche, alla categoria
del totalitarismo, e ad ogni forma di ripensamento critico delle
interpretazioni canoniche del recente passato. Il tabù storico è quello più
strenuamente presidiato, perché più direttamente e minacciosamente
politico. Ma nel frattempo, nel cordone sanitario steso intorno alla cultura
e agli autori considerati di destra (o semplicemente irriducibili alla
sinistra) si sono aperte innumerevoli falle, a cui i maître à penser del
politicamente corretto reagiscono con tattiche diverse. Si assiste quindi al
successo della casa editrice Adelphi, a un diffuso interesse per Nietzsche,
pensatori della crisi e scrittori mitteleuropei, ma insieme a ricorrenti
levate di scudi contro Céline, Jünger o Heidegger, per non parlare di
autori più decisamente consegnati alla destra come Julius Evola.
In
genere, dagli anni Ottanta ad oggi, la storia della cultura italiana si può
leggere anche come un disperato (ma efficace) tentativo di autodifesa
dall’inevitabile caduta di muri, divieti, barriere che la scomparsa delle
ideologie e la globalizzazione culturale ha comportato. L’accorato monito
di un intellettuale internazionalizzato come Umberto Eco, di fronte alla
possibile elezione a Bologna di un sindaco ex macellaio, permette di capire
come le categorie di “apocalittici” e “integrati” si possano
invertire e sovvertire quando si tratta di tutelare quello che resta di una
lunga storia di egemonia. La commistione, teorizzata e difesa in altri
campi, si arresta di fronte all’ultimo confine, la distinzione tra destra
e sinistra: il confine che consente la delegittimazione dell’altro,
additato come pericoloso avversario del bene comune. Eppure, nelle pagine
finali del suo saggio, Pierluigi Battista fa un breve elenco degli
irregolari della cultura italiana, che colpisce per il livello dei nomi e
anche per il numero: Gadda e Montale, Pareyson e Anceschi, Buzzati e
Landolfi, Praz e Longhi, Flaiano e Germi, e Ortese, Parise, Piovene,
Ceronetti, Sgalambro, Romeo, Ripellino, Pampaloni, Citati.... Troppi,
insinua l’autore, per essere solo degli “irregolari”. Ha forse ragione
Valerio Riva quando sostiene che l’editoria di sinistra si è finanziata
con i libri “di destra”, o almeno con quelli disimpegnati: costruendo
una facciata ideologica mantenuta economicamente da altri. Così, nella
cultura italiana, la facciata ideologica ha coperto una realtà che, a
distanza, appare composta perdipiù da talenti e posizioni non riconducibili
ad appartenenze precise, da vicende individuali sfumate nella marginalità
atipica, nella solitudine o nell’eccentricità.
(Ideazione Gennaio-Febbraio 2000)
|
|