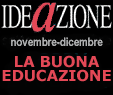Rileggere il
craxismo
DECISIONISTA A META'
di Piero
Melograni
Bettino
Craxi, segretario del Partito socialista italiano dal 1976 al 1993 e
presidente del Consiglio dei ministri tra l’83 e l’87, cercò di
spezzare il sistema consociativo sul quale si reggeva la politica italiana,
ma non ebbe successo. Fu ostacolato dal clima culturale e politico del
paese, dai legami esistenti tra il Partito comunista e la Democrazia
cristiana, dalla situazione internazionale, dalle debolezze storiche del
Partito socialista e dai suoi stessi difetti, benché questi fossero
accompagnati da qualità innegabili. Gli anni 1976-93, d’altra parte,
furono anni difficili, contrassegnati da un’ondata terroristica senza
precedenti, da stragi, dal sequestro e dall’uccisione di Aldo Moro, da
scandali come quelli della Lockheed o della loggia P2, dall’estendersi
della criminalità organizzata e, ovviamente, dalle sempre presenti
difficoltà economiche. La campagna giudiziaria di Mani Pulite, iniziata
dalla magistratura nel 1992, creò problemi inquietanti a tutta la classe
politica ma in particolare a Craxi, che funse da capro espiatorio.In un
libro pubblicato nel 1977, un anno dopo la sua elezione alla segreteria del
Psi, Craxi individuava nel legame esistente tra la Dc e il Pci, un grave
ostacolo alla affermazione socialista. Ci sono settori della Dc, scriveva,
«i quali puntano ormai dichiaratamente a un rapporto diretto con il Partito
comunista, negando, in modo anche insolente, ogni e qualunque ruolo e
funzione del Psi». Craxi voleva invece far sì che il suo partito operasse
come elemento sovvertitore nei confronti di tale rapporto. Non per caso
sulla copertina del libro pubblicato nel 1977, sotto al titolo Costruire il
futuro, campeggiava questo sottotitolo programmatico: come uscire dalla
crisi italiana?
Questa
l’alternativa socialista al capitalismo parassitario e al comunismo
burocratico. Erano tempi in cui risultava difficile a tanti, e soprattutto
ai socialisti, prendere di mira il comunismo, sia pure aggiungendovi il
qualificativo “burocratico”. Ma Craxi lo fece. E’ vero che anche il
Psi manteneva rapporti diretti e molto significativi con il Pci, grazie ad
antiche tradizioni ed alleanze. Questi rapporti risultavano essere
particolarmente rilevanti nelle amministrazioni locali, ma anche in esse il
leader socialista avrebbe preferito imporre una svolta. Psi e Pci
governavano insieme in molti comuni e in molte regioni, ma in questo campo,
osservò il leader del Psi, «non crescono solo fiori. Si sono manifestati e
si manifestano contrasti di impostazione e di gestione. Vi è un permanente
rifiuto e quindi una reazione del Partito socialista nei confronti di ogni
espressione di natura egemonica che nasce e può sempre nascere dal fondo più
dogmatico del partito più forte, tentato qualche volta di stare sempre al
centro di un sistema stellare di relazioni». Il sistema stellare doveva
insomma essere vanificato. Craxi mirava di certo a una crescita del consenso
elettorale e avrebbe voluto conquistare voti sia tra quanti votavano
democristiano, sia tra quanti votavano comunista. «Noi – scrisse con
ingenua fede – abbiamo alcuni vantaggi di partenza che non abbiamo mai
valorizzato per definirci meglio come un partito laico anche per i cattolici
che stanno a sinistra». E poi aggiunse, riferendosi anche al variegato
schieramento dei partiti e dei movimenti che si richiamavano alla classe
operaia: «Noi insisteremo per fare del Psi un nuovo polo di riferimento, di
attrazione e di aggregazione a sinistra».
Non
si può escludere che, in anni successivi al 1977, Craxi accantonasse gli
sforzi diretti a conquistare un ampio consenso. Luciano Cafagna, per
esempio, ha sostenuto che a un certo momento, dopo aver constatato il
successo del suo potere di coalizione, Craxi, forse, arrivò addirittura a
temere una crescita del consenso «per gli indesiderati obblighi che
potevano derivarne, non ultimo quello di essere sfidato a una esplicita
politica mitterandiana verso i comunisti, che avrebbe comunque implicato
paradossalmente un accrescimento della possibilità di influenza e controllo
di questi ultimi se avessero deciso di appoggiarlo». Ma questa rinunzia a
conquistare voti, se vi fu, si collocò in anni successivi al 1977 quando
Craxi era costretto a registrare, nonostante tutto, un sostanziale
esaurimento del suo programma innovatore. E, del resto, l’ipotesi che un
partito politico non desideri accrescere il suo consenso, già da sola
offrirebbe il destro per segnalare l’esistenza di una contraddizione
profonda, se non di una malattia mortale.
L’immagine
di Craxi è quella di un leader decisionista. Ma la nostra impressione è un
po’ diversa. Craxi “apparve” decisionista perché fu confrontato con
gli altri leader politici della Prima Repubblica tanto spesso
temporeggiatori, dubbiosi e dediti al compromesso fino alla patologia. In
realtà anche lui non riuscì a fare le scelte che sarebbero state
indispensabili per uscire dal pantano. Ci riferiamo, per essere precisi,
alle scelte indispensabili in tema di economia. E’ vero che ebbe
l’ardire di contrapporsi ai comunisti e a gran parte del mondo sindacale
quando tagliò tre punti della scala mobile nel febbraio 1984, e quando si
batté con successo contro quanti (Pci, Msi e la maggioranza della Cgil)
avrebbero voluto abrogare questo taglio con il referendum del giugno 1985.
Tuttavia il segretario del Psi non riuscì mai denunciare con forza tutte le
illusioni e le utopie che in tema di economia circolavano a sinistra, anche
all’interno del suo stesso partito. Craxi si richiamava alla tradizione
socialdemocratica di Filippo Turati, ma non trovò mai il coraggio, non
diciamo di proclamare che il socialismo era una dottrina arcaica e
fallimentare (proclamazione che in quegli anni sarebbe stata giudicata folle
dalla sinistra italiana), ma neppure di far fare al suo partito un bagno
socialdemocratico simile a quello che i suoi compagni tedeschi avevano fatto
a Bad Godesberg nel 1959. Se ne possono trovare le scusanti nel clima
politico-culturale dell’Italia di allora. Nelle elezioni generali tenutesi
fra il 1976 e il 1985, il Partito comunista e le liste collocate alla sua
sinistra raccolsero sempre qualcosa di più del 30 per cento dei voti. Alle
elezioni europee del 1984, il Pci scavalcò la Dc, diventando, col 33,3 per
cento, il primo partito. In quegli anni, nonostante Berlinguer e il
compromesso storico, larghissima parte degli elettori di sinistra ritenevano
che l’obiettivo strategico restasse ancora quello della rivoluzione.
Insistevano nel sostenere la “centralità” della classe operaia.
Giudicavano diabolici il profitto e le multinazionali. Scorgevano la via del
riscatto nella fine del sistema capitalistico. Ritenevano che il capitalismo
fosse causa di un impoverimento progressivo delle masse e, nello stesso
tempo, bollavano sprezzantemente i nuovi consumi di massa come consumismo
degenerato. L’economia era una scienza negletta, tanto vero che, nel
sistema economico nazionale, i salari potevano essere ancora considerati una
variabile indipendente. Nel 1978, allorché il segretario della Cgil,
Luciano Lama, si permise di sostenere il contrario, sollevò critiche aspre
da parte di molti esponenti della Cisl, della Uil, nonché da parte del
segretario aggiunto della stessa Cgil, Agostino Marianetti che, guarda caso,
apparteneva al Partito socialista. L’ignoranza in tema di economia e i
pregiudizi anticapitalistici riguardavano il Pci, larga parte degli ambienti
cattolici e i socialisti. Probabilmente lo stesso segretario del Partito
socialista era solo parzialmente consapevole delle grandiose novità del
mondo tecnologico. Certamente non decise mai di svelare ai suoi elettori
reali e potenziali che la crescita materiale degli ultimi decenni era dovuta
al fatto che l’Italia apparteneva al sistema capitalistico occidentale, e
che la classe politica avrebbe dovuto superare i ritardi culturali derivanti
da ideologie falsamente progressiste. Insomma, per compiere quell’opera di
modernizzazione alla quale dichiarava di aspirare, Craxi avrebbe dovuto
criticare con coraggio il socialismo, e quindi mettere in discussione
l’ideologia sulla quale poggiava il suo partito e sulla quale avrebbero
potuto poggiarsi le sue speranze di catturare consenso nell’elettorato
della sinistra comunista e cattolica. In certo qual modo egli avrebbe dovuto
compiere quell’opera di revisione culturale, e perfino storiografica, che
gli stessi dirigenti ex comunisti del Pds-Ds non sono riusciti ancora oggi
(1999) a compiere fino in fondo, condizionati – come essi sono – dal
loro passato e dal loro presente, vale a dire dal timore di mettersi troppo
in urto con una parte consistente della base elettorale.
Nella
prima metà degli anni Ottanta, quando fu presidente del Consiglio dei
ministri, Craxi poteva ritenere di avere davanti a sé abbastanza tempo
prima di decidere. La presenza di una potente Unione Sovietica e la
divisione dell’Europa in sfere di influenza avevano bloccato il sistema
politico italiano, nel quale si presentava “l’anomalia” di un Partito
comunista fortissimo e nello stesso tempo impossibilitato a governare. Quasi
nessuno presagiva un così rapido crollo del muro di Berlino, dell’impero
sovietico, dell’ideologia comunista. Craxi, insomma, temporeggiava, si
muoveva per piccoli passi e, peggio ancora, credeva di rafforzare il suo
partito facendogli conquistare potere negli enti pubblici e nella
contrattazione degli appalti. Già dal 1977, in quel libro che abbiamo
citato all’inizio di questo scritto (Costruire il futuro), Craxi aveva
disegnato un programma non esente da rischi affermando che i socialisti
dovevano «con vigore e con convinzione porre l’autofinanziamento al
centro della lotta per il rinnovamento del Partito». E aggiungeva: «Occorre
ottenere la mobilitazione di tutte le risorse interne per assicurare il
finanziamento della stampa e della editoria socialista, la qualificazione e
la formazione dei quadri; per assicurare le sedi e le attrezzature al
partito e alle altre strutture che fiancheggiano ed agevolano l’azione dei
socialisti. Sbaglia chi ritiene che queste questioni siano marginali. Aver
sottovalutato l’importanza politica dei problemi amministrativi è stato
errore grave. […] Dobbiamo fare presto e bene per assicurarci forza e
consistenza nella più rigorosa indipendenza e autonomia». Per il solo
Avanti!, il quotidiano che aveva conosciuto antiche glorie, si registrava un
disavanzo superiore ai quattro miliardi. Craxi suggeriva di istituire una
anagrafe patrimoniale dei dirigenti del partito e dei compagni che lo
rappresentavano all’esterno, dato che fin da allora circolavano voci
denigratorie. Ma si sa come queste cautele possano andare a finire.
Prevalsero i bisogni. E così, come abbiamo accennato all’inizio, proprio
il Partito socialista, e Craxi per esso, divenne il principale bersaglio di
Tangentopoli.
La
storia è troppo nota perché meriti qui di essere ancora una volta narrata.
Piuttosto resta da capire perché Craxi funzionò da capro espiatorio nella
campagna contro la corruzione. E’ infatti ancora da accertare se il
Partito socialista fosse davvero il più corrotto tra i partiti italiani e,
in caso affermativo, anche questo primato non ci sembrerebbe sufficiente a
spiegare il livore e l’accanimento che si diressero verso il suo leader.
Fra l’altro Bettino Craxi pronunciò alla Camera, il 29 aprile 1993,
l’unico discorso argomentato, serio e perfino nobile sulla corruzione
politica. Il fatto è che Craxi, nel corso degli anni, aveva attirato su di
sé l’avversione di moltissimi ambienti. Nel 1976 poteva dichiarare: «Io
sono un a-comunista viscerale, ma non per questo mi getterei tra le braccia
della Dc», e in tal modo rendeva esplicito il suo ruolo di disturbatore nei
confronti di tutti. Dalla seconda guerra mondiale in poi, il Partito
socialista era stato sempre accompagnato da un complesso di inferiorità
verso il Partito comunista, ma con Craxi questo complesso si spegneva e, nel
1986, lo stesso segretario del Psi arrivava a precisare: «Noi non siamo un
residuato storico né un’appendice nervosa del Pci». Si può capire
quindi come il Partito comunista, che aveva a lungo goduto della propria
superiorità, si adontasse nel vedere che il partito inferiore era guidato
da un ribelle. Non basta. Il personaggio Craxi poteva apparire arrogante e
autoritario. Di certo un disegnatore famoso come Giorgio Forattini lo
ritraeva con gli stivaloni, la camicia nera, il fez e magari il manganello
sulle pagine del quotidiano la Repubblica. Il pubblico di quel giornale, in
larga parte coincidente col popolo comunista, interpretò quei ritratti
senza molta ironia e senza alcuna simpatia. Il Pci, alquanto potente tra gli
intellettuali, nella stampa, nel cinema, nelle case editrici, nelle
università e perfino in molti salotti o in molte terrazze, era in grado di
legittimare e delegittimare con un ampio grado di discrezione. Craxi, che
non era disposto né a piegarsi, né a subire il primato di quel partito,
non venne mai completamente accettato e, con Tangentopoli, fu anzi chiamato
al rendiconto finale.
(Ideazione Gennaio-Febbraio 2000)
|
|