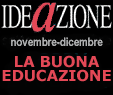Rileggere il
craxismo
UNA SFIDA MANCATA
di Giorgio Galli
«Fare
storia del presente è il più difficile degli esercizi». E’ quello nel
quale mi sono esercitato ormai da molti decenni. In particolare, per quanto
concerne il socialismo italiano e il Psi, una sua storia risalente ai primi
anni Ottanta (Ma l’idea non muore. Storia orgogliosa del socialismo
italiano, edito da Laterza e poi dal Club degli Editori) è stata oggetto di
un aggiornamento nel ’96 (Marco Tropea editore); e credo costituisca il
primo e forse tuttora unico tentativo di collocare il periodo craxiano in
una prospettiva di analisi storico-politica. Ovviamente utilizzando, in
questa chiave, anche gli atti giudiziari, pur nella convinzione, in questo
come in altri casi – ad esempio, la vicenda della lotta armata – che la
storia non la scrivono i magistrati. In
questo quadro non credo che Craxi abbia reinterpretato in modo originale la
tradizione socialdemocratica sotto il profilo ideologico; e, per quanto
riguarda la pratica politica, occorre tenere conto del fatto che egli è
arrivato alla segreteria di un partito che aveva meno del dieci per cento
dei voti e con una corrente che, pur avendo alle spalle il prestigio di
Nenni, era assolutamente minoritaria. L’impegno a superare questa
debolezza iniziale ha condizionato non solo le prime scelte della sua
segreteria, ma anche quelle successive. La stagione craxiana appartiene alla
tradizione culturale del Psi, che però già negli anni Sessanta e Settanta
(segreteria De Martino e Mancini) era un partito debole, inserito in un
sistema politico fortemente caratterizzato da quella che è stata definita
economia della corruzione. La rottura col passato è stata rappresentata dal
fatto che, con la segreteria Craxi, questa situazione è stata ritenuta non
modificabile, e quindi il contesto naturale nel quale la debolezza del Psi
avrebbe potuto essere superata soltanto sfruttando appieno tale tipo di
economia.
Per
quanto riguarda l’oggi, dopo il craxismo, va detto che una parte
dell’eredità riformista della tradizione (non mi pare appropriato il
termine “mito”) socialdemocratica era già da decenni appannaggio del
Pci ed è attualmente gestita dai postcomunisti. Questo è quello che rimane
in Italia, in una fase di difficoltà della socialdemocrazia anche a livello
europeo.Il modo di Craxi di gestire il potere è stato caratterizzato da tre
fattori: una grande spregiudicatezza, il superamento del complesso di
inferiorità nei rapporti coi comunisti, il mancato superamento di tale
complesso di inferiorità nei confronti del mondo cattolico e del suo peso
nella società italiana (situazione propria di tutta la sinistra, da
Togliatti e Nenni sin dall’immediato dopoguerra a Berlinguer sino alla sua
morte). Questi aspetti sono più importanti dell’aver accentuato la
personalizzazione individuale della leadership politica, che, sotto questo
profilo, ha effettivamente anticipato alcune caratteristiche dello stile
politico degli anni Novanta. In ogni caso il termine weberiano di
“carisma” va usato con molta cautela; e non si addice al caso di Craxi.
E’ vero che il cosiddetto “culto della personalità” ha suscitato
anche una violenta avversione personale nei confronti di Craxi. La prima
ragione va individuata nel citato uso spregiudicato dell’economia della
corruzione. La seconda ragione in una arroganza – fatta propria dai
seguaci – questa sì molto lontana dalla tradizione e dallo stile del
socialismo italiano.
La
regola non scritta (soprattutto dei democristiani) era di non ostentare la
corruzione e la pratica tangentizia. Con Craxi, il personale politico
socialista ha fatto il contrario (e questo ha anche facilitato il lavoro dei
magistrati, soprattutto a Milano, capitale del craxismo). Nonostante ciò,
la proposta craxiana di Grande Riforma (presidenzialismo compreso) era stata
accolta con favore da estesi settori della pubblica opinione (i sondaggi
davano per Craxi indici di preferenza ben superiori a quelli del suo
partito). In questo senso, non mi pare che il “decisionismo” lo abbia
danneggiato. Ma è stato egli stesso a rinunciare al suo progetto per una
duplice ragione: non sfidare apertamente la Dc (il non superato complesso di
inferiorità verso i cattolici, di cui si è detto); e la convinzione di
poter ereditare l’elettorato di un Pci in crisi, quasi automaticamente,
senza la necessità di iniziative di ampio respiro.Sotto questo aspetto, la
stagione craxiana si colloca nell’evoluzione dall’interno di un sistema
politico rimasto sostanzialmente lo stesso, con un ruolo socialista che è
rimasto subalterno al potere democristiano, che è continuato. Proprio per
tale ragione il cosiddetto riformismo socialista craxiano non è riuscito ad
approfittare della crisi del comunismo mondiale; si è collocato
all’interno del sistema di potere democristiano in declino e non lo ha
sfidato nei suoi punti deboli: l’economia della corruzione, che anzi, come
si è detto, il Psi utilizzava e il logorio istituzionale, che Craxi intuiva
(appunto proponendo la Grande Riforma), ma che, in sostanza, ha finito col
subire. E il Pci, pur coinvolto nel consociazionismo lo era meno
nell’economia della corruzione, tanto da poter insistere sulla
berlingueriana “questione morale”.
Il
debito pubblico cresceva proprio nel quadro dell’economia della corruzione
e dell’uso delle sue risorse per organizzare il consenso. Gli aspetti
negativi di questa situazione erano attenuati da quello che è stato
definito “grande e veloce sviluppo economico”, accompagnato da
modernizzazione sociale. Craxi non ha promosso, ma certamente accompagnato,
questo processo. Ma, all’inizio degli anni Novanta, gli aspetti negativi
sono emersi prepotentemente e ci hanno lasciato un’eredità che ancora
pesa, anche nel campo di quella che viene definita liberalizzazione
dell’etere, in realtà un duopolio che, col conflitto di interessi che ha
creato, complica tuttora l’evoluzione positiva del nostro sistema
politico. Proprio mentre questi aspetti negativi cominciavano ad emergere,
Craxi è sembrato perdere quella capacità di intuizione politica che lo
aveva caratterizzato nei momenti migliori (la tutela della dignità
nazionale dei giorni di Sigonella contro l’invadenza americana). Forse
hanno influito anche le condizioni di salute, dopo la crisi dei primi di
gennaio del 1990. Questo è un fattore del quale, nel “fare storia del
presente”, non si è tenuto abbastanza conto. Potrebbe contribuire a
spiegare la reazione “con fastidio e arroganza” a un’opinione pubblica
che assumeva un atteggiamento sempre più apertamente critico nei confronti
del sistema politico, spingendosi a tentare strade nuove (il successo della
Lega nelle elezioni regionali del 1990), per cui chi aveva proposto la
Grande Riforma istituzionale finì col suggerire di “andare al mare”
agli italiani che la chiedevano, attraverso un referendum sia pure limitato
nel fine specifico (quello sulla preferenza unica del 1991).
Comunque,
al di là di questo fattore (le condizioni di salute) credo che il destino
politico di Craxi sia stato determinato dalle due carenze di fondo di cui si
è detto: l’esitazione nello sfidare la Dc e la convinzione di poter
raccogliere automaticamente l’eredità elettorale dei comunisti in crisi.
L’accettazione in posizione subalterna dell’ultimo governo Andreotti del
1991 (quando il partito repubblicano di Giorgio La Malfa lasciò la
maggioranza proprio per incompatibilità con la Dc) pose la premessa per la
sconfitta della coalizione di governo nell’aprile 1992. Durante quella
campagna elettorale, Craxi era tanto lontano dal presagire la sua fine
politica da far tappezzare l’Italia di sue gigantografie con lo slogan
“un governo per la ripresa”, quello che egli stesso avrebbe dovuto
guidare se le elezioni fossero state vinte dalla coalizione che aveva
sostenuto l’ultimo esecutivo Andreotti. Fu la sua sconfitta che mise in
crisi la Prima Repubblica. Essa non fu “abbattuta” da un “ciclone
giudiziario”. Fu l’elettorato che chiese alla classe politica di
rinnovarla. Questa non raccolse la richiesta e la magistratura finì con
l’assumere il ruolo surrogatorio di interprete della pubblica opinione,
agendo nell’ambito proprio del suo ruolo, in precedenza sovente
trascurato. In questa situazione nell’estate 1992 (coi traumi degli
omicidi di Falcone e Borsellino, che da un lato evidenziavano la profonda
crisi del sistema politico e dall’altro conferivano alla magistratura il
crisma dell’eroico sacrificio) e ancora nell’aprile 1993 (col discorso
alla Camera sulla richiesta di autorizzazione a procedere) fu lo stesso
Craxi a erigersi come interprete di una intera classe e di una intera
stagione politica, quasi costruendo e prefigurando una situazione che ne
faceva l’unico capro espiatorio. Forse sperava di mobilitare attorno a sé
una classe politica invece rassegnata alla sconfitta, non tanto di fronte ai
giudici, quanto di fronte a un’opinione pubblica che – allora – si
esprimeva coi fax, dopo essersi espressa elettoralmente, per chiedere
mutamenti di comportamento che esigevano anche il cambiamento dei soggetti
che avrebbero potuto realizzarlo. Oggi mi pare che i dubbi della pubblica
opinione e degli osservatori politici riguardino più il mancato verificarsi
del mutamento, che non la sorte delle singole persone.
Il
problema non mi sembra di “moralità”, ma propriamente politico: perché
si è bloccata la transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica? Perché
è fallita la commissione Bicamerale per le riforme istituzionali?Si tratta,
in ultima analisi, di capire quali elementi della società e del sistema
politico italiani, presenti nel decennio del protagonismo craxiano,
perdurino, tuttora influenti, e forse allora radicatisi, sino a rendere
particolarmente difficile e ancora di durata indefinibile quella che era
stata definita una fase di transizione; e che, invece, può risultare una
stagione politica con proprie connotazioni precise.
(Ideazione Gennaio-Febbraio 2000)
|
|