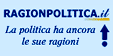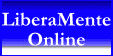|
Una rivoluzione antitotalitaria
di Raymond Aron*
da Ideazione di marzo-aprile 2006
«L’unica controrivoluzione
che ebbe veramente luogo fu quella realizzata dalle autorità sovietiche,
quando, con l’uso di forze armate dotate di schiacciante superiorità,
sostituirono in Ungheria a un regime socialista, ma democratico, un
regime di polizia» (Sui fatti d’Ungheria. Testo del Rapporto del
Comitato Speciale dell’Onu, Roma 1957).
Un anno è trascorso dai tragici giorni del novembre 1956, quando i carri
armati russi reprimevano la rivoluzione ungherese col ferro e col fuoco,
mentre gli aerei francesi e inglesi schiacciavano gli aeroporti egiziani
sotto le bombe. Gli statisti francesi ed inglesi che, probabilmente,
giudicarono il momento propizio alla loro impresa, sono responsabili di
un’aberrazione, che può essere spiegata ma non scusata dalla loro
insigne mediocrità. Allora toccammo il fondo della disperazione
politica, in rivolta contro tutto e contro tutti, poco inclini sia a
condividere l’indignazione virtuosa degli Stati Uniti contro i loro
alleati sia a perdonare il machiavellismo primario dei nostri
governanti. La rivoluzione ungherese apparteneva alla storia universale,
la nazionalizzazione del canale di Suez era un episodio del conflitto
tra il mondo arabo-musulmano e gli Occidentali. La storia sarà severa
non per le intenzioni ma per la cecità dei ministri francesi ed inglesi.
Un anno basta, ahimé!, a placare le indignazioni, a rassicurare le
coscienze. Il signor Vercors da tempo ha ripreso il dialogo con gli
scrittori sovietici. I signori B. e K. hanno ritrovato il sorriso e
compiuto altri viaggi. L’ordine regna a Budapest. Il signor Kàdàr
presiede un governo che si definisce operaio-contadino. Circa
duecentomila ungheresi hanno lasciato la loro patria. Gli eroi della
rivoluzione sono dispersi nei paesi d’accoglienza. I più felici, che
possedevano qualche qualifica e la cui salute non era motivo di
preoccupazione per i funzionari dell’immigrazione americani, si trovano
ormai dall’altra parte dell’Atlantico. Alcune migliaia di emigrati si
interrogano sul futuro nell’Austria neutrale, che non cessa di dare
lezioni di generosità ai grandi dell’Occidente.
Oggi le invettive, le arringhe, le mozioni di protesta sarebbero
ugualmente derisorie! I carri armati russi hanno provvisoriamente
restaurato l’impero sovietico d’Europa. A che pro perorare una causa,
respingere la tesi sovietica della controrivoluzione? I racconti di
testimoni occidentali, di emigrati ungheresi, i tentativi di fare storia
si sono moltiplicati. Soltanto i fanatici e i ciechi volontari possono
nutrire ancora qualche dubbio. Limitiamoci qui a citare il riassunto
fatto dalla stessa Commissione d’inchiesta dell’onu, le conclusioni cui
sono pervenuti i rappresentanti d’Australia, di Ceylon, della Danimarca,
della Tunisia e dell’Uruguay, incaricati di indagare sugli avvenimenti
d’Ungheria:
«1) Ciò che avvenne in Ungheria fu una spontanea insurrezione nazionale
dovuta ad una lunga situazione di sopraffazioni. Una di queste fu la
posizione di inferiorità dell’Ungheria nei confronti dell’Urss.
2) L’insurrezione fu condotta da studenti, lavoratori, soldati ed
intellettuali, molti dei quali comunisti o ex comunisti. Coloro che vi
parteciparono insistettero perché il socialismo democratico fosse la
base della struttura politica dell’Ungheria e perché la riforma agraria
e altre realizzazioni positive fossero salvaguardate. È falso che
l’insurrezione sia stata fomentata da circoli reazionari ungheresi o che
fosse appoggiata da circoli “imperialisti” occidentali.
3) L’insurrezione non era avvenuta in seguito ad un piano prestabilito,
ma i partecipanti furono colti di sorpresa. La sua tempestività coincise
col fortunato movimento polacco per una maggior indipendenza dall’Urss e
con la delusione causata dal discorso di Erno Gerö al suo ritorno dalla
Jugoslavia il 23 ottobre, quando invece si sperava che egli avrebbe
mostrato un atteggiamento di simpatia verso le richieste popolari
formulate il 22 ottobre dagli studenti ungheresi.
4) Sembrerebbe che le autorità sovietiche abbiano fin dal 20 ottobre
preso delle misure per rendere possibile un intervento armato. Esistono
prove di movimenti di truppe o di piani di movimenti di truppe da quel
giorno in poi e forze sovietiche fuori del territorio ungherese furono
chiamate anche per il primo intervento. In Ungheria, segni di
opposizione erano evidenti prima del 23 ottobre.
5) Le dimostrazioni del 23 ottobre da principio erano tranquille, e
nessuna prova è stata data che i dimostranti volessero usare la forza.
Il cambiamento fu dovuto all’azione dell’avh, quando essa aprì il fuoco
sulla popolazione adunata dinanzi al Palazzo della Radio e quando a
Budapest comparvero i soldati russi in assetto di guerra.
6) Nagy dichiarò che non aveva rivolto alcun invito alle autorità
sovietiche ad intervenire e il Comitato non ha nessuna prova che tale
invito sia stato rivolto o meno. Analoga considerazione va applicata
all’invito rivolto da parte del Governo Kàdàr alle truppe sovietiche ad
intervenire in una seconda occasione. Vi sono però serie prove per
confermare che i preparativi sovietici per un intervento si stavano
facendo fin dai primi giorni di ottobre.
7) Nagy non fu dapprima libero di esercitare i pieni poteri della sua
carica. Quando la stretta dell’avh si allentò, il vero potere era nelle
mani dei Consigli Rivoluzionari ed Operai. Nagy, visto che i suoi
connazionali erano concordi nel loro desiderio di altre forme di governo
e della partenza delle truppe sovietiche, si mise dalla parte degli
insorti.
8) Durante i pochi giorni di libertà, il carattere popolare
dell’insurrezione fu provato dall’apparire d’una stampa e d’una radio
libere, oltre che dalla soddisfazione generale del popolo.
9) I linciaggi e le violenze commessi dalla folla furono, nella maggior
parte dei casi, diretti contro membri dell’Avh e coloro che si riteneva
avessero collaborato con essa.
10) I passi fatti dai Consigli Operai durante questo periodo avevano lo
scopo di dare ai lavoratori un reale controllo delle imprese
nazionalizzate e di abolire istituzioni impopolari, come le norme di
produzione. Frattanto negoziati erano in corso per il completo ritiro
delle truppe sovietiche e la vita a Budapest cominciava a tornare alla
normalità.
11) In contrasto con le richieste poste a quell’epoca per il ripristino
dei diritti politici, sta il fatto che i diritti umani fondamentali del
popolo ungherese erano stati violati dal Governo ungherese prima del 23
ottobre, particolarmente nell’autunno 1955, e tali violazioni sono
ricominciate dopo il 4 novembre. I molti trattamenti inumani e le
torture da parte dell’avh debbono essere accettati come veri. Nel
tentativo di spezzare la rivoluzione, un certo numero di ungheresi, fra
cui molte donne, furono deportati nell’Unione Sovietica ed è probabile
che alcuni di essi non abbiano fatto ritorno alle loro case.
12) Dopo il secondo intervento sovietico del 4 novembre, non vi furono
manifestazioni di appoggio da parte della popolazione al Governo Kàdàr.
Kàdàr ha proceduto gradualmente per distruggere il potere dei
lavoratori. Gravi misure repressive furono adottate e le elezioni
generali furono rimandate di due anni. Kàdàr rifiutò, data la
situazione, di trattare il ritiro delle truppe sovietiche. Soltanto una
piccola parte dei 190.000 ungheresi che lasciarono il paese, accettarono
l’invito a ritornarvi.
13) L’interesse da parte delle Nazioni Unite per la questione ungherese
era giuridicamente inoppugnabile e il paragrafo 7 dell’articolo 2 della
Carta non comporta obbiezioni in proposito. Un massiccio intervento
armato da parte di una Potenza nel territorio di un’altra Potenza con la
chiara intenzione di interferire nei suoi affari interni, deve, secondo
la stessa definizione dell’aggressione data dall’Unione Sovietica,
ritenersi una questione di interesse internazionale».
Sebbene gli avvenimenti stessi e il loro significato non lascino più,
oggi, sostanzialmente, spazio al dubbio, il Libro Bianco, nato dallo
sforzo paziente e colto di M.J. Lasky, offre una lettura appassionante.
Esso ci fa rivivere quei giorni tragici così come li abbiamo vissuti,
divisi tra il timore della probabile catastrofe e la speranza quasi
folle di un’imprevedibile vittoria. Ci ricorda cosa furono quei giorni
d’entusiasmo nell’Ungheria libera, tra l’evacuazione delle truppe russe
da Budapest e il secondo intervento. Ci permette di seguire le versioni
successive degli avvenimenti sulla stampa ungherese, jugoslava, polacca.
Dal confronto di tante menzogne o mezze verità sorge miracolosamente,
evidente, irrefutabile, la semplice verità. Nessuno dei racconti,
scritti frettolosamente dagli storici in quest’anno, mi pare abbia il
valore scientifico o, posso dire, artistico di questa collezione di
documenti contemporanei.
I
L’Europa orientale nel suo insieme offriva al mondo esterno
un’uniformità di facciata. In Polonia come in Romania, in Cecoslovacchia
come in Ungheria si erano succedute le medesime tappe della
sovietizzazione, si osservavano le stesse istituzioni politiche ed
economiche e, dalla morte di Stalin, la stessa alternanza di tensione e
distensione, gli stessi tentativi di liberalizzazione dall’alto.
In nessun luogo il partito comunista avrebbe potuto impadronirsi da solo
del potere. Dovunque aveva avuto bisogno dell’aiuto dell’armata rossa.
La forza autentica del partito comunista variava secondo i paesi. Le
elezioni libere del 1945-46 gli davano in Cecoslovacchia più di un
terzo, in Ungheria il 17 per cento dei voti. In Polonia ed in Germania
Orientale la fusione dei partiti socialista e comunista non permetteva
di misurare esattamente la loro rispettiva clientela. Il passaggio dalla
coalizione antifascista al fronte nazionale fu operato in tutte le
democrazie popolari secondo procedimenti politico-polizieschi analoghi,
ricorrendo a quella che Rákosi battezzò “tattica del salame”. In
Ungheria, il partito dei piccoli proprietari aveva ottenuto la
maggioranza assoluta dei suffragi (57 per cento), ma il partito
comunista, grazie all’appoggio delle autorità d’occupazione, conservò il
ministero dell’Interno e il controllo della polizia (avh). I partiti non
comunisti in qualche anno furono ridotti all’impotenza: i loro capi
furono arrestati con il pretesto di aver partecipato a complotti
inventati di sana pianta. Comunisti od opportunisti in combutta con i
comunisti presero il posto dei dirigenti eliminati. Verso la fine del
1948, a prescindere dal fatto che i partiti non comunisti erano stati
ufficialmente sciolti o messi in riga mantenendo un’esistenza di
facciata, il partito legato a Mosca, esecutore delle sue volontà, era
padrone unico del potere.
La dissidenza di Tito suscitò una crisi che, una volta di più, sembrò
illustrare e consacrare l’omogeneità dell’Europa orientale, l’unità del
suo destino. Ciascuna delle democrazie popolari conobbe un’epurazione.
Anche in quel caso ci si affrettò a trovare una formula generale: furono
eliminati i comunisti che durante la guerra non erano stati a Mosca ma
si erano dati alla macchia, incolpati di complicità con Tito o di
deviazione nazionalista. Questa formula si applicava a Kostov, a Gomulka
e a Rajk. Si applicava male a Slansky in Cecoslovacchia o alle vittime
dell’epurazione in Albania o in Romania. Indubbiamente si poteva
ristabilire l’accordo tra la teoria e la realtà con qualche ipotesi
supplementare. In ogni epurazione, la polizia staliniana pratica
l’amalgama. La sorte di Slansky poteva essere imputabile alla campagna
antisemita scatenata a Mosca, al ruolo svolto dal segretario del partito
ceco nell’aiuto a Israele. Altrove, l’epurazione non colpiva i comunisti
nazionali perché non ne trovava. Uno dei dirigenti era nondimeno
sacrificato alla necessaria “vigilanza proletaria”. Gli osservatori in
Occidente non attribuivano importanza a ciò che doveva in seguito
apparire una differenza capitale: Rajk aveva confessato ed era stato
messo a morte, Gomulka era stato arrestato, torturato ma non processato
e giustiziato. I dirigenti stalinisti polacchi non avevano spinto il
loro fanatismo o servilismo tanto in là quanto quelli di Praga o di
Budapest.
È a partire dal 1953 che parvero emergere le differenze tra democrazie
popolari, dall’esterno. Se l’attenuazione del terrore, partita da Mosca,
raggiunse tutti i satelliti, la distensione fu segnata in modo ineguale,
così come la revisione dei piani economici, decisa nel 1953-54,
all’epoca in cui Malenkov era presidente del Consiglio. Unica fu, così
pare, la disgrazia di Nagy ed il ritorno in forze di Rákosi nell’aprile
1955. La ripresa dello stalinismo in Ungheria andava controcorrente
all’interno dell’universo sovietico: tale situazione fu accentuata, nel
febbraio 1956, dal XX Congresso del partito. A partire dal 1956, la
linea generale di Mosca resta visibile in tutte le democrazie popolari,
ma l’interpretazione di questa linea, la reazione nazionale alla libertà
di critica retrospettiva accordata da Mosca varia da paese a paese. Tra
la Polonia e l’Ungheria, dove gli intellettuali denunciano con passione
gli orrori dello stalinismo, e la Romania e la Cecoslovacchia, dove la
disciplina si mantiene nella denuncia del culto della personalità, il
divario è immenso. Queste differenze sono state talvolta spiegate con i
soli avvenimenti della fase post-staliniana, ma se sono apparse in
questo periodo, non esistevano forse anche in precedenza?
Tutte le democrazie popolari hanno fondamentalmente il medesimo regime
economico, ma si potrebbe anche dire che tutte le democrazie occidentali
hanno “lo stesso regime economico”: non siamo però inclini a ignorare le
differenze fra economia americana ed economia francese. L’atteggiamento
degli operai americani nei confronti del capitalismo si spiega con i
risultati che questo dà oltre Atlantico, così come l’atteggiamento
dell’operaio francese nei confronti del capitalismo si spiega con
l’esperienza che ne ha lui stesso. In quale misura “lo stesso regime
sovietico” non produce effetti diversi?
Ad un livello elevato di astrazione, il problema si porrebbe nei termini
seguenti: fino a che punto il regime (modo di funzionamento, statuto di
proprietà) determina il volume della produzione, il ritmo d’espansione,
le condizioni di vita? Il sostenitore più feroce dei meccanismi del
mercato non va oltre l’affermazione che la pianificazione comporta
perdite più grandi delle imperfezioni del meccanismo dei prezzi.
Supponendo un regime mutuato da quello dell’Unione Sovietica, e imposto
ad un paese con il livello d’industrializzazione della Gran Bretagna o
degli Stati Uniti, né il livello di produzione né il tenore di vita si
allineerebbero a quelli dell’Unione Sovietica o dell’Ungheria. In altri
termini, a supporre anche che le democrazie popolari abbiano tutte lo
stesso regime, i popoli ne avrebbero un’esperienza diversa, secondo lo
stato dell’economia all’inizio dell’esperienza, secondo le risorse della
collettività.
È vero che, all’inizio della sovietizzazione, i paesi dell’Europa
orientale si trovavano tutti in condizioni analoghe (salvo la
Cecoslovacchia). Tutti, infatti, erano economie prevalentemente agrarie,
dove l’insufficiente sviluppo industriale non riusciva ad assorbire
l’eccedenza di manodopera, che rimaneva semidisoccupata nelle campagne.
L’Unione Sovietica poté imporre non solo la propria teoria ma anche la
sua applicazione, perché i paesi, ridotti allo stato di satelliti,
avevano da svolgere compiti analoghi: assorbire il surDaily di
popolazione contadina nell’industria, dunque investire molto e consumare
poco. Per di più, questo compito comune i governi delle democrazie
popolari vollero eseguirlo con gli stessi procedimenti: pianificazione
rigida, priorità assoluta all’industria pesante, prezzi fissati
dall’ufficio del piano, collettivizzazione dell’agricoltura più rapida
possibile. In altri termini, ciò che spinse gli osservatori ad ammettere
l’omogeneità della zona sovietica non fu la convinzione implicita che la
pianificazione o la proprietà collettiva dessero ovunque gli stessi
risultati, per giunta deplorevoli, ma la constatazione di uno stesso
sistema di pianificazione, orientato verso obiettivi analoghi.
Anche prescindendo dalla Cecoslovacchia, intervengono nondimeno due
differenze: le condizioni naturali proprie a ciascun paese e il livello
d’inefficienza del regime. Rispetto a ciò, l’Ungheria mi pare
rappresentare un caso estremo. L’edificazione di un’industria pesante in
un paese che non ha né carbone coke né ferro era dettata dal dogma e
contraria al buon senso. Più il paese è piccolo e più diventa assurdo lo
sforzo per riprodurre la struttura dell’Unione Sovietica su scala
microscopica. La collettivizzazione dell’agricoltura, pochi anni dopo
una riforma agraria che aveva liquidato la grande proprietà terriera di
origine feudale, doveva suscitare una resistenza feroce.
Questa politica, manifestamente contraria agli interessi e alle
aspirazioni del popolo ungherese, fu condotta con una brutalità spietata
dal partito comunista. In origine, questo non era un semplice strumento
delle autorità d’occupazione. All’indomani della seconda guerra mondiale
operai, liberali, intellettuali hanno in alcuni casi riposto la loro
fede nel partito, in altri sognato di costruire in cooperazione con esso
una Ungheria nuova, autenticamente democratica e socialista, nel senso
che queste parole rivestono in Occidente. Però man mano che le
condizioni materiali della vita e il terrore si aggravavano, il regime
appariva come il camuffamento o l’agente di trasmissione della
dominazione russa. Tutto si svolgeva come se ci si ingegnasse ad
esasperare la nazione: i piani economici condannavano gli operai a
salari da carestia, la collettivizzazione e le consegne forzate a basso
prezzo erano odiose ai contadini, la soppressione di ogni libertà
intellettuale rinchiudeva gli intellettuali nel dilemma del silenzio o
dell’epurazione, la polizia segreta minacciava tutti gli ungheresi e non
risparmiava neppure gli stalinisti più risoluti, l’insegnamento del
russo era obbligatorio, le uniformi dell’esercito erano simili a quelle
dell’occupante, la stella rossa ornava tutti gli emblemi. A questo
popolo privato di ragioni di vita, una stampa schiava ripeteva ogni
giorno che era felice e che doveva ringraziare i russi per la sua
felicità.
In verità, ci si spiega agevolmente l’odio unanime del popolo ungherese
contro l’Unione Sovietica ed i suoi agenti in Ungheria, i comunisti. Ci
si spiega meno che quest’odio abbia sorpreso coloro che ne erano oggetto
e i progressisti, in Francia e altrove.
Il caso dell’Ungheria è eccezionale? Non è facile rispondere
categoricamente a questo interrogativo, in mancanza di informazioni
sicure. Ma i fatti autorizzano delle ipotesi perlomeno verosimili.
Nessun regime sovietico (neanche quello della Russia in capo a
quarant’anni) prende in considerazione elezioni libere o discussioni
pubbliche dei principi. In nessun paese dell’Europa orientale il partito
comunista sarebbe in grado di vincere elezioni autentiche, non ne era
capace dieci anni fa, non ne sarebbe capace oggi. Ripetiamo
instancabilmente che il partito che pretende d’incarnare le masse, il
proletariato o la Storia, rifiuta ostinatamente di sottoporsi alla
decisione degli uomini liberi.
Le ragioni di questa ostilità non sono del resto affatto misteriose. In
tutti i paesi di regime sovietico(1) i fenomeni ungheresi si ripetono. I
contadini sono obbligati o minacciati dalla collettivizzazione, esposti
alle vessazioni delle autorità, da cui ricevono direttive, spesso
inapplicabili, e alle quali debbono consegnare i loro prodotti a basso
prezzo. Gli operai sono, per la maggior parte, malpagati. Stimato in
franchi, il salario medio in Ungheria era inferiore a 15.000 franchi al
mese. Infine, gli intellettuali e i militanti sono, anch’essi, esposti
al terrore, spogliati di ogni libertà di creazione o di critica. Solo i
credenti o gli opportunisti sono appagati da un regime che annuncia la
libertà e sopprime tutte le libertà, promette l’eguaglianza e
ricostituisce una classe privilegiata, garantisce l’indipendenza delle
nazioni e consacra l’imperialismo russo. Secondo il funzionamento del
regime, l’ostilità dei contadini è più o meno forte, il numero degli
operai o dei quadri soddisfatti del loro posto in una società aperta
agli ambiziosi più o meno grande, l’amarezza degli intellettuali messi
in riga e dei militanti delusi più o meno viva.
In Cecoslovacchia, tutti i fenomeni sono attenuati. Si è sviluppata
l’industria pesante alle spese dell’industria leggera. Il processo, che
non è razionale nei confronti dell’interesse ceco, è malgrado tutto meno
penoso di quello dell’industrializzazione forzata di una popolazione
prevalentemente di agraria. Il tenore di vita è di gra lunga inferiore a
quanto sarebbe se il paese fosse restato dalla parte giusta della
cortina di ferro. Il malcontento è ovunque ma si è lontani dalla
disperazione o dall’esasperazione dell’Ungheria. Si voterebbe contro il
partito se si potesse votare, ma si sa che non si voterà e ce ne si fa
una ragione.
Forse si può spiegare il contrasto fra la sottomissione ceca e l’eroismo
ungherese o polacco con le circostanze storiche oltre a quelle
contingenti. Il nazionalismo ungherese o polacco non è forse più forte
del nazionalismo romeno o ceco, ma certo è diverso. Ungheria e Polonia,
al tempo delle monarchie, sono state grandi potenze su scala europea. Il
nazionalismo di questi popoli-padroni è stato segnato dall’impronta
aristocratica, è rivolto verso l’Est in un atteggiamento di ostilità o
di resistenza. Cattolici, unanimemente o in maggioranza, i due popoli
sono estranei alla tradizione ortodossa, ribelli alla religione secolare
di Stato che il comunismo russo porta con sé.
Il sentimento nazionale dei polacchi e degli ungheresi è stato a lungo
legato alla rappresentanza di uno Stato potente. L’eroe della
rivoluzione del 848, Kossuth, che voleva liberare il suo popolo, era
indifferente alle rivendicazioni nazionali delle popolazioni riunite
sotto la corona di santo Stefano. Tra le due guerre, la protesta
ungherese invocava dei diritti storici più che la volontà delle
popolazioni. (Similmente, la Repubblica di Polonia nello stesso periodo
inglobava circa un terzo di minoranze). Nel 1945, nel 1957, la nostalgia
del passato era soffocata dalle prove del presente. Il popolo ungherese
voleva vivere razionalmente, non più ricostituire un regno
multinazionale, che aveva avuto la sua grandezza ma che il movimento
delle idee trasformava in anacronismo. A lungo inquadrati e animati da
un’aristocrazia, polacchi e ungheresi hanno manifestato, nella loro
condotta collettiva, il senso dei valori nobili e il disprezzo della
ragione borghese2.
II
Quale che sia la parte negli avvenimenti del 1956 che si debba far
risalire alle forze profonde, sorte dalla tradizione, sono le cause più
recenti a rendere intellegibili gli avvenimenti (non li si sarebbero
previsti, li si comprendono a posteriori). Il primo ritorno al potere di
Nagy aveva comportato una “liberalizzazione” più spinta che negli altri
paesi delle democrazie popolari (liberazione di molti detenuti politici,
diritto ai contadini di lasciare gli sfruttamenti collettivi, riduzione
del programma di investimenti). Nel 1955, Nagy fu accusato una seconda
volta di deviazione e cacciato contemporaneamente dal partito e dalla
presidenza del Consiglio. Rákosi allora tentò, nel 1955-56, di praticare
egli stesso, dall’alto, la destalinizzazione, che il XX Congresso e il
discorso di Kruscev contro Stalin rendevano obbligatoria. L’uomo più di
ogni altro responsabile del processo e della morte di Rajk, proclamava
che l’ex dirigente del partito era stato vittima di un’ingiustizia, di
accuse prefabbricate. La squadra staliniana Rákosi-Gerö, la peggiore
probabilmente di tutte le squadre staliniane d’Europa orientale, la più
detestata, tentava di mantenersi adottando la destalinizzazione come
aveva adottato tutte le precedenti linee di Mosca. Ma la commedia della
libertà non si rappresenta impunemente.
Nel corso di tutto il 1956 abbiamo assistito da lontano, con stupore
crescente, allo svolgimento del nuovo corso. Le istituzioni sovietiche
rimanevano al loro posto, ma la censura degli scritti, la disciplina
della parola, l’ortodossia verbale erano come misteriosamente scomparse.
Scrittori polacchi e ungheresi paragonavano Stalin a Hitler, reclamavano
la libertà, non quella che, grazie a un gioco dialettico, si compie
attraverso la coincidenza con le opinioni dei governanti, la vera
libertà, tutta formale, per parlare come i marxisti, che si esprime con
il diritto a dire no, ad amare e detestare, il diritto di scegliere… Un
regime di economia pianificata, di partito unico, di industrializzazione
accelerata, che camuffava la dominazione straniera, poteva per giunta
permettersi il lusso di una stampa, di una letteratura libere? Ci
domandavamo ansiosamente quanto tempo il regime avrebbe tollerato la
libertà e quale, tra il regime e la libertà, sarebbe perito.
Nell’ottobre-novembre 1956, la libertà, in Polonia come in Ungheria, ha
prevalso sul regime. In Polonia, la libertà ha raggiunto con il regime
un compromesso accettabile per i russi. In Ungheria, la libertà
vittoriosa è stata distrutta dai carri armati dell’armata che seguita ad
essere chiamata rossa.
Da un anno, si è indefinitamente speculato sulle cause del successo
polacco e della catastrofe ungherese. Se lasciamo da parte l’ipotesi,
che non è esclusa, di una volontà cosciente dei governanti russi di
provocare una rivolta in Ungheria per poterla schiacciare in stile
spettacolare, è sufficiente evocare due situazioni, due scene storiche
per comprendere il destino dei due popoli. Quando Kruscev e i suoi
compagni sbarcarono a Varsavia, il comitato centrale del partito operaio
polacco era in seduta, deciso a eleggere Gomulka primo segretario del
partito. Cyrankiewicz, Ochab, che avevano ricoperto i ruoli dominanti
nel periodo staliniano, avevano fatto blocco con Gomulka contro gli
staliniani irriducibili del gruppo Natolin. Un amico di Gomulka,
Spycholski, era stato portato al comando dell’esercito, le guardie
operaie erano mobilitate. Forte dell’appoggio del partito, Gomulka
poteva dare ai delegati del Presidium la scelta tra l’accettazione di un
regime che si dichiarava comunista e restava fedele al patto di Varsavia
e l’avventura di una sanguinosa repressione. L’esercito polacco non
avrebbe tenuto testa a quello russo più di quello ungherese (la
repressione sarebbe durata qualche giorno in più), l’Occidente non
sarebbe venuto in soccorso della Polonia più che dell’Ungheria. Ma i
dirigenti di Mosca avevano interesse a evitare, se era possibile, il
ricorso ai carri armati, che lacerava le apparenze della liberazione
proletaria e scopriva la realtà dell’oppressione. Kruscev, Mikojan,
Molotov, Zhukov scelsero tra le due alternative scelsero la prima.
In nessun momento della rivoluzione ungherese, una simile alternativa fu
offerta ai russi. Non per colpa dei rivoluzionari; la situazione non era
la stessa. Gomulka e i suoi amici erano stati imprigionati e torturati,
Rajk e i suoi erano morti. Cyrankiewicz non ispirava ai revisionisti un
disprezzo o un odio tali da rendere impossibile la sua presenza alla
testa del governo nell’era post-staliniana. Rákosi e Gerö sapevano quali
sentimenti ispiravano, e si aggrapparono il più a lungo possibile alla
vecchia politica. Un riallineamento del partito ungherese sull’esempio
del partito polacco era escluso. I revisionisti erano troppo numerosi
tra i comunisti, troppo lontani dai rakosisti, perché il partito potesse
mantenere la sua unità e conservare il controllo degli eventi a partire
dal momento in cui il potere di Rákosi e della polizia politica si era
spezzato. La disgrazia per l’Ungheria fu di avere un partito allo stesso
tempo troppo e non abbastanza ungherese: nella sua maggioranza, i membri
del partito condividevano la rivolta e le aspirazioni delle masse, una
minoranza resistette fino in fondo al movimento, più per difendere i
propri interessi che per fanatismo. Questa minoranza era troppo
comunista (russa) per cedere, gli altri non lo erano abbastanza da
trovare una soluzione accettabile al Cremlino.
Il carattere del partito comunista mi pare la causa principale del corso
preso dalla destalinizzazione nei diversi paesi dell’Europa orientale.
Nei regimi burocratici, le forze politiche, i sentimenti delle masse si
esprimono nelle lotte di fazione, almeno fino al momento in cui le
emozioni popolari non si trasformano in azione. Allora accade
l’imprevisto. Ogni interpretazione astratta lascia un margine: una
rivoluzione è un avvenimento. Prima di una certa data, gli stessi attori
la ritenevano inconcepibile. Dopo un certo giorno, una certa ora,
nessuno può più fermarla.
Il discorso di Gerö, dopo il suo ritorno dalla Jugoslavia, esasperò la
popolazione. Gli spari sulla folla, assembrata davanti al palazzo della
Radio, scatenarono la rivoluzione. A partire da allora, la tragedia
seguì il suo corso. Nagy fu compromesso dall’intervento dell’esercito
russo di cui gli si attribuì falsamente la responsabilità. Quando riuscì
a discolparsi, i rivoluzionari avevano preso il potere in tutto il paese
e le rivendicazioni erano fuoriuscite dal quadro del regime sovietico.
La denuncia del patto di Varsavia e elezioni libere avrebbero distrutto
i due pilastri del comunismo, il ruolo dirigente dell’Unione Sovietica,
l’onnipotenza del partito.
Il 23 ottobre operai, studenti, scrittori sarebbero stati
tranquillizzati dalla costituzione di un governo Nagy e dalla promessa
di un regime più liberale e più nazionale. Una settimana più tardi i
rivoluzionari vittoriosi, sotto l’emblema di Kossuth, reclamavano tutte
le libertà, di stampa, di religione, di opinioni politiche, reclamavano
un Parlamento e la competizione tra i partiti, reclamavano
l’indipendenza totale del paese. Ciò che si era creduto impossibile – un
popolo che abbatteva da solo uno Stato totalitario – era improvvisamente
realtà. Le parole d’ordine del 1848, libertà, nazione, giustizia
ritrovavano, contro la tirannia burocratica e la dominazione russa, la
loro eterna freschezza.
Follia, si dirà: come avrebbero potuto gli uomini del Cremlino accettare
questo disastro morale, politico, militare? Certo, riflettendoci a
sangue freddo, questo eroismo era folle, ma che ci vengano risparmiati i
rimpianti tendenziosi, le insinuazioni sordide. Capi e militanti della
rivoluzione ungherese sapevano meglio di noi i pericoli che correvano.
La denuncia del patto di Varsavia non è stata la causa del secondo
intervento russo, ma un supremo tentativo di prevenirlo. Il discorso del
cardinal Mindszenty era nobile e dignitoso. Se avesse potuto evitare o
modificare alcune espressioni che possono essergli rimproverate, non
sarebbe cambiato nulla. Dopo anni senza contatti col mondo esterno, il
cardinale sarebbe stato scusato se, a causa di affermazioni inopportune,
avesse commesso degli errori politici. A dispetto delle leggende, non ne
commise.
Non è il caso di mettere a posteriori il sigillo della fatalità su una
successione di eventi che si immagina agevolmente altra, alla sola
condizione di sostituire un dettaglio a un altro o, semplicemente, di
avanzare o retrocedere nel tempo tale decisione o tale incidente. Ma
sarebbe più indecente ancora strappare alla tragedia di un popolo la sua
patetica grandezza accusando la debolezza di un capo o la passione di
una folla. Rákosi e i suoi spinsero l’ostinazione troppo oltre, gli
ungheresi detestavano troppo i loro padroni e, attraverso di essi, la
dominazione russa: se l’esplosione si produceva, il popolo doveva andare
fino in fondo alle sue esigenze, che Kruscev e forse più ancora il
maresciallo Zhukov dovevano giudicare incompatibili con gli interessi
dell’impero russo. Ovviamente la propaganda comunista ha denunciato la
rivoluzione ungherese come una controrivoluzione. Se per
controrivoluzione s’intende la ricostituzione del regime che esisteva
prima della rivoluzione o la restaurazione dei privilegiati, vittime
della rivoluzione, l’argomentazione è infondata e non merita di essere
discussa. Se per controrivoluzione s’intende ogni deviazione in rapporto
al regime comunista, la rivoluzione ungherese è controrivoluzione nel
modo in cui la restaurazione della democrazia parlamentare in Italia e
in Germania è controrivoluzione in rapporto al fascismo e al
nazionalsocialismo. La rivoluzione ungherese, in effetti, tendeva a
creare o a ristabilire istituzioni che i comunisti ritengono
inseparabili dalla democrazia borghese, dunque anteriori, nel processo
storico, al regime comunista. Ma in questo caso ciò che si presta a
critiche è la filosofia che immagina una linea unica di evoluzione
storica e, ponendo il comunismo nello stadio finale, non ha altro nome
per una rivoluzione anticomunista che quello di controrivoluzione.
Come hanno fatto notare parecchi commentatori, le classi spodestate da
una rivoluzione sociale, nobili, grandi proprietari, banchieri, non
possono esse stesse scatenare una controrivoluzione. Perdendo terre e
capitali, hanno perduto la fonte della loro influenza o della loro
autorità. Come avrebbero potuto gli aristocratici ungheresi manipolare i
contadini divenuti proprietari o i lavoratori delle fabbriche? Perché
gli studenti, gli operai, i soldati avrebbero dovuto seguire
volontariamente i rappresentanti di una classe oggi spodestata, che la
stessa propaganda denuncia per aver oppresso e sfruttato il popolo ai
tempi della sua potenza? Incriminare gli “ispiratori” o gli “agenti
dell’imperialismo occidentale” vuol dire imitare le peggiori aberrazioni
di coloro per i quali si professa disprezzo, i borghesi del secolo
scorso che, incapaci di comprendere il risentimento delle masse,
imputano la rivolta popolare a qualche individuo satanico.
D’altronde, se la “democrazia socialista”, l’unica rivoluzionaria,
implica il dominio di un partito unico, gli ungheresi si avviavano verso
ciò che i comunisti, a loro massima onta, sono costretti a chiamare
controrivoluzionario, poiché la democrazia, che gli ungheresi
fervidamente auspicavano, per la quale erano pronti a morire, era la
democrazia che tanti nostri intellettuali rinnegano e chiamano
“formale”. Radio Kossuth, statua di Bem, circolo Petöfi, questi nomi ci
riportano al tempo in cui nazione e libertà andavano di pari passo. La
nuova alleanza, conclusa in Ungheria, non è né anacronistica né
accidentale.
Nella Politica, Aristotele, dopo aver comparato i principali regimi, si
dedica ad uno studio delle rivoluzioni che determinano la loro fine.
Basta rompere radicalmente con la rappresentazione unilineare della
storia: di colpo, democrazia borghese e sovietismo cessano di apparire
come due momenti successivi di un movimento, sono due sovrastrutture di
una società industriale. S’indagherà su come muoiono i regimi sovietici
allo stesso modo in cui ci s’interroga sulle modalità di rovesciamento
dei regimi democratici.
Conosciamo tre tipi di rivoluzioni che mettono fine alle democrazie:
l’arrivo al potere di un partito autoritario per via legale, con il
favore della paralisi del Parlamento e grazie all’investitura del capo
dello Stato (avvento di Mussolini e di Hitler); il colpo di Stato,
pacifico o sanguinoso (dal pronunciamento [sic] sudamericano fino alla
guerra civile spagnola); infine, le disfatte militari, l’invasione o la
liberazione (Francia del 1940, Europa orientale). Nessuno dubitava che
un regime totalitario potesse essere anch’esso vittima di una disfatta
militare. La deposizione di Mussolini, quella di Peron provavano che un
regime, in sella da lungo tempo, non era al riparo di un complotto di
forze “reazionarie” o “liberali”, ordito dal legittimo re o da generali
ostili. Ma né il fascismo né il peronismo erano totalitari. Il complotto
del 20 luglio era fallito nel III Reich.
Non si era ancora osservata, in questo secolo, contro uno Stato
autoritario, una rivoluzione popolare che cominciasse con una sommossa e
finisse con la conquista dello Stato. Ebbene, ciò che si è prodotto in
Ungheria, è precisamente una rivoluzione conforme alla leggenda del
Diciannovesimo secolo, che inizia in strada e si conclude al palazzo del
governo, che la lentezza delle autorità e l’impazienza delle masse
spingono in avanti verso un estremismo che nessuno aveva preso in
considerazione al punto di partenza. Ci si ricordi: nel febbraio 1848,
in Francia, l’opposizione dinastica non voleva rovesciare la monarchia
orleanista. Le dimissioni di Guizot, l’allargamento del diritto di
suffragio sarebbero bastate se queste misure fossero state prese in
tempo. Forse anche le dimissioni di Guizot sarebbero potute ancora
bastare se alcuni soldati, sparando accidentalmente, non avessero
esasperato la folla. Lo scenario si riprodusse esattamente in Ungheria,
più di un secolo dopo.
La rivoluzione ungherese era vittoriosa in tutto il paese e non nella
sola capitale, il partito comunista si era disintegrato, i militanti
troppo compromessi nello stalinismo e i membri della polizia politica
tentavano di nascondersi: gli ex comunisti si erano mischiati in massa
all’insurrezione, non difendevano più il potere, condividevano la
volontà comune. Giornalisti e sociologi ripetevano che un popolo non può
prevalere su un regime totalitario: in un certo senso avevano ragione.
Ma il regime ungherese tollerava, da mesi, la libertà di parola, la
classe dirigente aveva perso unità e fiducia in se stessa. La
rivoluzione d’Ottobre è stata preceduta da un fenomeno di
detotalitarismo. “La cricca dirigente”, Rákosi-Gerö, si aggrappava al
potere, mentre la maggior parte dei membri del Politburo voleva di
sbarazzarsi di loro (i più compromessi per salvarsi), la stampa era
ridiventata per metà libera, gli intellettuali criticavano,
interrogavano, rivendicavano, come nei giorni migliori della democrazia
occidentale; infine, la maggioranza dei membri del partito e
dell’amministrazione, per ostilità ai russi, per orrore della vecchia
tirannia, parteggiava con gli insorti, prima ancora che risuonasse il
primo sparo.
Una rivoluzione antitotalitaria è possibile come le rivoluzioni contro
la monarchia o l’assolutismo erano possibili nel secolo scorso. Ma se
sono necessarie tutte le circostanze, la cui congiunzione favorì la
rivoluzione ungherese, quante volte si ripeterà un tale incontro
(direzione del partito divisa, militanti del partito ostili,
esasperazione operaia e contadina, unanimità patriottica contro lo
straniero, libertà di parola, rifiuto dell’esercito di combattere gli
insorti)? Malgrado tutto, le due condizioni essenziali – solidarietà
profonda dei militanti del partito con il popolo, rifiuto dei soldati e
degli ufficiali di reprimere l’insurrezione – non sono forse rare in
Europa orientale, forse sono virtualmente realizzate, con la sola
presenza dell’armata rossa a mantenere un’apparenza opposta. Così si
scopre il significato esatto della rivoluzione ungherese: rivoluzione
antitotalitaria, certo, ma rivoluzione contro uno pseudo-totalitarismo.
Infatti ci si chiede se un totalitarismo imposto dall’esterno, percepito
come il dominio di una potenza straniera, è autenticamente totalitario,
e se beneficia di quel minimo di adesione popolare senza il quale le
istituzioni sono come dei gusci vuoti.
III
Molti occidentali temevano che le giovani generazioni fossero
conquistate dal vangelo di Marx, così come è stato interpretato da Lenin
e Stalin. Oggi questi timori devono essere dissipati. A parte qualche
filosofo, la gente da entrambi i lati della cortina di ferro dà lo
stesso senso alla parola libertà. La libertà non è, per l’uomo comune,
acconsentire alla necessità ma il diritto assieme alla possibilità
materiale di protestare contro coloro che si spacciano per interpreti
della necessità.
Gli operai che hanno conosciuto il sindacalismo occidentale, quelli
della Germania orientale, della Cecoslovacchia e perfino dell’Ungheria,
non possono non riconoscere la differenza tra i sindacati che spingono
allo sforzo, e i sindacati che chiedono salari più elevati o il
miglioramento delle condizioni di lavoro, tra i sindacati che sono dalla
parte dei padroni con il pretesto che il padrone unico è lo Stato
socialista, e i sindacati che sono dalla parte dei lavoratori, perché i
padroni sono dei capitalisti. Gli operai venuti recentemente dalle
campagne, che ignorano tutto delle istituzioni della democrazia
borghese, non possono non provare dei sentimenti paragonabili a quelli
dei proletari nei sobborghi delle grandi città europee, all’inizio del
secolo scorso, quando Marx osservava le loro sofferenze e s’indignava
contro l’indifferente ferocia dei capitalisti. Poco importa che il
filosofo, nel suo studio parigino, consideri o meno la burocrazia come
una classe. Il fatto è che la nuova società comporta grandi differenze
di reddito, una minoranza che possiede privilegi sostanziali, di natura
materiale e morale. Il socialismo implica, nella sua versione
staliniana, che invece di vituperare i privilegi come in Occidente, li
si neghi sistematicamente o li si dichiari come espressione della
giustizia o della legge della Storia. Anche se il sociologo o
l’economista, tutto ben considerato, giudicano positivo il bilancio del
regime sovietico, questo non potrebbe suscitare l’entusiasmo di coloro
che pagano il prezzo dell’industrializzazione necessaria. Se il regime
succede a una fase di inflazione e di caos come in Cina, la garanzia
della ciotola di riso diventa un progresso reale, percepito come tale
dalla folla. Se il regime viene dopo una fase di umiliazione nazionale e
riscuote successi esterni, come in Russia e in Cina, il sentimento di
costruire l’avvenire, l’orgoglio della potenza collettiva compensano
forse i sacrifici e le sofferenze. I figli di operai e di contadini che,
grazie alla rivoluzione e all’edificazione socialista, possono studiare
ed elevarsi nella gerarchia sociale, sono riconoscenti al regime
dell’opportunità che ha dato loro.
In Ungheria, anche la minoranza attivista era finalmente esasperata.
Perché gli studenti, molti dei quali venivano da famiglie operaie e
contadine, perché i giovani operai che avevano subito da dieci anni la
propaganda ufficiale, perché gli scrittori e gli artisti, molti dei
quali erano materialmente dei privilegiati, si sono finalmente levati
contro il regime? Tutte le testimonianze mi paiono rendere lo stesso
suono, suggerire la stessa storia. Questi uomini, giovani o vecchi,
comunisti o non comunisti, cattolici o non credenti, ex socialisti o ex
nazional-contadini, si sono rivoltati alle contraddizioni tra le
ideologie e la realtà. Questi rivoluzionari si richiamavano agli ideali
del regime che combattevano. Fermiamoci un momento su questo punto,
poiché è decisivo per comprendere la situazione ungherese e anche per
comprendere il nostro tempo.
La dottrina comunista, il marxismo di Marx, quello di Lenin, non
apportano un sistema di valori originale. La visione borghese del mondo
e della società si opponeva alla visione tradizionale della Chiesa
cattolica e dell’Ancien Régime. Il socialismo pretende di realizzare i
valori cui si richiama la borghesia, far partecipare tutti gli uomini ai
benefici della scienza e dell’industria, instaurare un’autentica
democrazia, strappare l’economia alla paralisi capitalista, salvare gli
operai dallo sfruttamento e dalla povertà. Il regno del partito unico fu
dapprima giustificato con la dittatura del proletariato, dunque
considerato transitorio; l’ortodossia intellettuale dello Stato fu
introdotta invocando la necessità dell’edificazione socialista, senza
mai abbandonare i principi della scienza o della libertà intellettuale.
La disuguaglianza economica è accettata in quanto necessaria nella fase
del socialismo (a ciascuno secondo le sua opera), ma i privilegi
inutili, quelli che non favoriscono la crescita economica, restano
condannati riguardo alla dottrina.
Le rivendicazioni materiali e morali dell’insurrezione ungherese, nel
corso della prima fase, potevano senza ipocrisia essere presentate come
il ritorno alla verità socialista dopo “il culto della personalità” e “i
crimini della cricca Rákosi”. Il miglioramento delle condizioni di vita
era forse in contraddizione con gli obiettivi scelti dai pianificatori,
con un ritmo d’industrializzazione troppo rapido; la libertà
intellettuale è, di fatto, in contraddizione con la pratica del regime
sovietico sotto Stalin, per certi aspetti sotto Lenin; l’indipendenza
nazionale è certamente in contraddizione con la realtà dell’impero
sovieto-russo: né l’elevamento del tenore di vita, né la liberazione del
pensiero, né l’eguaglianza delle nazioni sono in contraddizione con
l’idea socialista o perfino la propaganda di Mosca.
Le elezioni libere e la pluralità dei partiti, incompatibili con il
bolscevismo fin dal 1918 (data della dissoluzione da parte di Lenin
dell’Assemblea costituente liberamente eletta), inaccettabili ai
dirigenti dell’Unione sovietica e delle democrazie popolari, non sono in
contraddizione con l’idea ispiratrice e l’obiettivo finale del
socialismo. I dottrinari sovietici pretendono che le elezioni in
Occidente non siano libere perché manipolate dai “monopoli”, talvolta
ipotizzano che dopo l’edificazione del socialismo le elezioni potrebbero
essere libere, nel senso occidentale del termine. Il comunismo pretende
di volere una libertà più reale di quella delle democrazie occidentali,
mentre il nazismo voleva eliminare i “falsi” valori della tradizione
giudaico-cristiana.
Questo antagonismo tra teoria e pratica del sovietismo rende ugualmente
intellegibili due evoluzioni tra gli intellettuali del regime, una verso
la rivolta, l’altra verso l’adattamento, con quella miscela
caratteristica di fanatismo, di opportunismo e di cinismo che Milosz ha
descritto ne La mente prigioniera.
La dottrina (o la propaganda) comunista, in parte responsabile della
rivolta contro la pratica sovietica, indicava anche le concezioni che i
rivoluzionari avevano dell’avvenire. Nessuno può dire quale Ungheria gli
ungheresi, sbarazzatisi dell’esercito russo, avrebbero costruito nella
libertà, ma su un punto i capi dei partiti ricostituiti restavano
socialisti: se prendevano in considerazione il mantenimento o la
restaurazione di una certa proprietà privata nell’artigianato,
l’agricoltura, il commercio, non mettevano in discussione la proprietà
collettiva delle fabbriche o l’idea della pianificazione. Gli avversari
del totalitarismo staliniano, dall’altra parte della cortina di ferro,
sono acquisiti all’anticapitalismo. Essi cercano un terzo termine che
elimini la tirannia staliniana senza implicare il ritorno alla proprietà
privata degli strumenti di produzione.
I
n Ungheria e in Polonia, il comunismo, per la sua ideologia più ancora
che per le sue istituzioni, ha esercitato un’azione profonda nel senso
democratico ed ugualitario. Esso ha liquidato i residui di una struttura
sociale derivante dal feudalesimo, ha fatto apparire evidentemente
auspicabile la riduzione della distanza sociale tra gli individui e le
classi. Nell’accumulare le rovine, la guerra aveva preparato la
proletarizzazione di popoli interi. I comunisti, forse contro i loro
stessi desideri, hanno eretto a ideale l’uguaglianza delle condizioni.
In Polonia e in Ungheria, i comunisti si situavano all’avanguardia del
movimento laico, secolare, razionalista. Per gli staliniani,
l’opposizione alla lunga più temibile non era quella di cui sopra, e
neppure quella della Chiesa cattolica, ma quella degli uomini di
sinistra, comunisti o no, delusi dal contrasto tra la teoria, liberale
ed egualitaria, e la pratica, autoritaria, gerarchica.
Di nuovo, si pone la questione, il caso dell’Ungheria è estremo o
eccezionale? Che sia estremo, non si può dubitarne. Il contrasto tra
teoria e pratica non è dappertutto così clamoroso. Le masse e le élite
non reagiscono ovunque con la stessa violenza, forse non reagiscono
ovunque nella stessa maniera. La minoranza privilegiata che, in
Cecoslovacchia o in Unione Sovietica gode (o godrà da qui a qualche
anno) di condizioni d’esistenza paragonabili a quelle della borghesia
occidentale (qualche libertà in meno) dimentica (o ignora) il divario
tra le speranze della Rivoluzione lontana e la realtà di una gerarchia
amministrativa e di uno Stato autoritario. Le masse scendono (o
scenderanno) a patti con un regime che garantisce loro un impiego e
offre (oppure offrirà) loro, anno più anno meno, un lento aumento dei
salari. Non si possono però eludere due domande. Il richiamarsi ad un
millenarismo non costituisce causa di debolezza per un regime
burocratico? Un regime che, di fatto, prolunga la tradizione del
dispotismo orientale, non è forse logorato da una segreta contraddizione
fintantoché pretende di incarnare lo sbocco del razionalismo
occidentale?
Il marxismo-leninismo è una versione, tra le altre, del millenarismo
rivoluzionario. Conquista le folle, convince gli intellettuali nei paesi
che soffrono di povertà, di sfruttamento, che hanno perso fiducia nelle
riforme, nei metodi parlamentari. Dottrina d’opposizione, fermento di
rivolta, il marxismo-leninismo promette lo sviluppo delle forze di
produzione, il progresso morale, l’uguaglianza fra gli Stati, la
scomparsa delle classi, il rispetto dei valori umanistici. Che si
giudichino efficaci o meno i procedimenti di edificazione socialista, un
regime scaturito dal marxismo-leninismo, anche se si spoglia dei tratti
patologici dello stalinismo, ricostituisce le strutture fondamentali del
dispotismo orientale, così come le descrivevano gli autori del secolo
XVIII e le analizzano i moderni sociologi.
Un regime sovietico tende alla concentrazione di tutto il potere,
politico e sociale, nelle mani di una minoranza. La soppressione di ogni
proprietà privata, la distruzione dei partiti, la messa in riga delle
Chiese non lasciano sussistere alcun centro di forze al di fuori dello
Stato. Questo segna un ritorno alla struttura elementare del dispotismo,
alla dualità della massa governata e della gerarchia, simultaneamente
sociale, amministrativa, politica. L’autorità incondizionata appartiene
di volta in volta allo Stato maggiore del partito, ad un solo uomo, di
nuovo allo Stato maggiore. Un tale regime differisce meno dalla
tradizione russa che dalla democrazia occidentale. Sarebbero stati la
limitazione del potere statale, la moltiplicazione dei focolai autonomi
di potenza sociale o d’autorità politica a segnare una rottura radicale
col passato. Il bolscevismo fu una rivoluzione, ma nel senso originale:
riportò la società russa, dopo l’intermezzo della libertà, tra febbraio
e novembre 1917, nella linea del dispotismo.
Forse il popolo russo si sottomette più agevolmente a questo regime
degli altri popoli d’Europa orientale. Non solo perché in Russia il
regime è nazionale, ma perché gli altri popoli d’Europa orientale erano
stati, da secoli, formati dalla civiltà occidentale, avevano conosciuto
la separazione del potere temporale e del potere spirituale, il
movimento dei Lumi, i valori razionali e democratici. Il comunismo
seduceva alcuni intellettuali e rivoluzionari, perché sembrava
prolungare e realizzare le aspirazioni “progressiste”. Il compromesso
russo tra le aspirazioni liberali e la tradizione dispotica è più
estraneo ai polacchi e agli ungheresi che ai russi.
Nella stessa Russia tale compromesso è duraturo? La società industriale
s’inserisce negli ambiti del dispotismo orientale? La realtà di un
regime autoritario e burocratico logora progressivamente il
millenarismo. Il regime può vivere senza essere sostenuto da una fede.
Ma le rivendicazioni delle masse che chiedono maggior benessere, quelle
dei privilegiati che chiedono maggior libertà, l’indisciplina ideologica
degli uni e degli altri non impongono forse, alla lunga, dei cambiamenti
tali da toccare l’essenza del totalitarismo, l’essenza del dispotismo
burocratico?
IV
Gli interrogativi riguardano l’avvenire. Il presente è altro e nessuna
letteratura deve dissimularne l’orrore. Imre Nagy è in prigione, János
Kàdàr, immagine perfetta del traditore, traditore di se stesso così come
degli altri, sfila nella capitale come rappresentante della dittatura
del proletariato. Arresti ed esecuzioni continuano. La nazione ungherese
è ancora una volta decimata. Essa ha perso i migliori tra i suoi figli
nelle prigioni o in esilio. Il maresciallo Zhukov, che più di ogni altro
fu responsabile della repressione, sarà ricevuto domani, se lo desidera,
dal generale Eisenhower, a Washington, in tutta cordialità. I capi dei
due imperi abbracciano con lo sguardo la carta dei continenti. Cosa sono
dieci milioni di ungheresi al cospetto di centinaia di milioni di
persone che hanno a loro carico? Qual è il posto stesso dell’intera
Europa nei calcoli planetari?
L’Occidente è in qualche modo responsabile della tragedia? Avrebbe
potuto prevenirla? Avrebbe potuto impedire ai russi di schiacciare la
rivolta di un popolo? Ancora una volta, ahimé!, credo si debba
rispondere di no. Coloro che accusano l’Occidente ignorano i fatti o si
crogiolano nella demagogia.
Tralasciamo il ruolo di Radio Free Europe(3) e degli “agenti
dell’imperialismo occidentale”(4). Torniamo, un istante, sulla
coincidenza della spedizione di Suez con gli avvenimenti d’Ungheria.
L’indignazione si disperse tra l’intervento russo e l’aggressione
franco-britannica. Ciascuno scelse l’oggetto della propria collera. Vi
furono coloro che giustificarono la prima e denunciarono la seconda (i
comunisti), quelli che denunciarono la prima e giustificarono la seconda
(i difensori dei governi francese e inglese), quelli che denunciarono
entrambe, gli uni con uguale vigore, gli altri facendo una differenza.
Il primo ministro dell’India era più ardente contro l’aggressione
franco-inglese che contro l’intervento russo. Gli intellettuali
francesi, al di fuori dei comunisti e dei progressisti, erano in maggior
parte più scatenati contro l’intervento russo che contro l’aggressione
franco-inglese. Sebbene ostile alla spedizione di Suez, appartengo a
quest’ultima categoria. Nessuno è emotivamente “neutro” o “obiettivo”.
Secondo il formalismo della legge internazionale, Francia e Gran
Bretagna, mi pare, erano aggressori. Quale che sia il giudizio
giuridico, morale o politico che si porta sulla nazionalizzazione del
canale di Suez, l’atto del colonnello Nasser non dava alla Francia e
alla Gran Bretagna il diritto di occupare militarmente la zona del
canale. La nazionalizzazione durava da più di tre mesi quando le truppe
israeliane varcarono la frontiera e Parigi e Londra inviarono il loro
ultimatum. In quel momento, la Gran Bretagna e la Francia negoziavano
con l’Egitto il futuro status del canale. Lo scarto tra i negoziatori
non era tale da giustificare legalmente o anche politicamente il ricorso
alla forza. Francia e Israele avevano solidi motivi di lamentela contro
l’Egitto e il presidente Nasser. Costui accumulava le armi e non faceva
mistero della sua intenzione di usarle contro Israele. La ribellione
algerina era sostenuta, rifornita d’armi dai servizi segreti
dell’esercito egiziano. Il presidente Nasser aveva disatteso le regole
non scritte del buoncostume diplomatico, non si era comportato in modo
conforme allo spirito della Carta, prima che Francia e Gran Bretagna ne
violassero la lettera. Anche la Gran Bretagna, che aveva minori motivi
di litigio con l’Egitto, poteva pensare che le sue posizioni nel mar
Rosso e nel golfo Persico non avrebbero resistito ad un clamoroso
trionfo del bikbachi, idolo del nazionalismo arabo.
Nondimeno, il signor Nehru e gran parte dell’opinione afroasiatica erano
più sensibili all’aggressione commessa da paesi europei, colonialisti,
contro un paese di civiltà non occidentale, appena uscito dal giogo
imperialista. Quando i bianchi si opprimono a vicenda, gli indiani sono
portati a prendere un atteggiamento neutro, accompagnati dal disilluso
commento: che altro ci si può aspettare dagli europei (o dai bianchi o
dai colonialisti)! Niente di più certo che questo atteggiamento si
combini con un inconscio opportunismo (l’Unione Sovietica è potente e
temibile).
Questa ingiustizia spontanea dell’opinione afroasiatica s’incontra con
un giudizio affatto diverso, rigorosamente politico, dettato, per larga
parte, dalla diplomazia americana. Francia e Gran Bretagna hanno violato
il diritto non scritto delle genti fissato, in ogni epoca, dalle potenze
dominanti. Gli Stati Uniti hanno decretato che, nelle zone contestate,
non si debba ricorrere a eserciti regolari. Non varcare le frontiere
diventa, in questo caso, un principio fondamentale. L’infiltrazione dei
feddayn, l’invio d’armi ai ribelli algerini sono spiacevoli ma fanno
parte dei mezzi correnti della guerra fredda. I raid di rappresaglia
israeliani sono già oggetto di un apprezzamento meno indulgente.
L’operazione del Sinai è giudicata inammissibile. Questo diritto delle
genti americane è, senza alcun dubbio, sfavorevole alle nazioni europee.
In un certo modo equivale a legittimare la guerriglia.
L’Unione Sovietica ha impiegato un esercito regolare, qualche migliaio
di carri armati e decine di migliaia di uomini contro un piccolo popolo
inerme. L’opinione americana ne è stata meno commossa di quella europea.
Dai comunisti non ci si aspettava nient’altro, mentre non ci si sarebbe
mai immaginati che Francia e Gran Bretagna, paesi alleati e democratici,
facessero la figura degli aggressori. Ma queste sono giustificazioni o
razionalizzazioni. La verità è che il diritto non scritto delle genti
dell’età atomica autorizza l’Unione Sovietica a fare qualunque cosa
nella sua zona. L’Ungheria apparteneva, appartiene ancora a questa zona.
Se la spedizione di Suez non avesse avuto luogo, i russi avrebbero
represso comunque la rivoluzione ungherese e l’Occidente sarebbe restato
fermo, ingannando la sua incapacità di agire con sincere manifestazioni
d’indignazione. Coloro, dunque, che denunciano la passività
dell’Occidente, dovrebbero dirci cosa avrebbe potuto essere fatto.
Ebbene, in queste situazioni estreme, l’alternativa è semplice, brutale:
o l’intervento militare, o l’astensione, camuffata da proteste verbali.
Non esiste terzo termine. Chi rifiuta il secondo senza accettare
esplicitamente il primo illude sé stesso, a meno che non inganni i
propri lettori. Si può concepire un terzo termine: la minaccia
d’intervento militare, ma questa minaccia (volontari o esercito
regolare) non verrebbe presa sul serio dall’Unione Sovietica se non a
condizione di essere pienamente assunta dai governanti e dai popoli
d’Occidente. Ebbene, questi non hanno mai preso in considerazione una
guerra contro l’Unione Sovietica per liberare i paesi d’Europa
orientale, non hanno neanche mai voluto correrne il rischio. Ci si
risparmi le facili proposizioni (al condizionale): l’intervento
occidentale non avrebbe comportato la guerra, la minaccia sarebbe
bastata. Per salvare l’Ungheria, gli Stati Uniti avrebbero dovuto
correre un rischio di guerra globale. Non l’hanno corso, neanche gli
europei l’avrebbero corso, se la decisione fosse dipesa da loro. Stati
Uniti e Unione Sovietica, uniti contro la guerra atomica, rispettano
vicendevolmente le loro zone di dominio. Queste zone non sono chiuse
alla propaganda del rivale, non sono aperte agli eserciti.
L’Ungheria non avrebbe potuto essere salvata che dalla ripugnanza
sovietica ad un’azione militare che significava, di per se stessa, una
sconfitta politica. Il corso degli eventi, se non una decisione
precedente, doveva condurre il Presidium ed i capi militari sovietici a
preferire il costo morale della repressione alla disgregazione del loro
impero europeo. Molti comunisti polacchi, le cui simpatie vanno
all’Ungheria, mormorano, in privato, che “i russi non potevano fare
altrimenti”. Sul piano della politica di potenza, può darsi. Ma che dire
di una liberazione che si conclude con questo massacro? Che pensare
degli intellettuali occidentali che hanno acclamato questo regime
tirannico per otto anni? Che condannano la repressione ungherese senza
condannare le loro stesse compromissioni di ieri con i carnefici? La
rivoluzione ungherese, la più pura del nostro tempo(5), è finita in
disastro. La rivoluzione polacca, che si è fermata al limite
dell’irreparabile, è stata provvisoriamente tollerata dai dirigenti
russi. In Ungheria, alla repressione è seguita una “reazione”
stalinista.
La lezione che bisogna avere il coraggio di trarre risolutamente è
chiara: è nell’interesse comune dei popoli prigionieri e dell’Occidente
che l’opposizione al comunismo dimori provvisoriamente all’interno del
regime. Poiché l’Occidente non può né vuole intervenire, poiché l’Unione
Sovietica ha i mezzi e la determinazione necessaria a schiacciare le
rivoluzioni, la sola prospettiva – al di fuori dell’eventuale
evacuazione simultanea delle due parti d’Europa da parte degli eserciti
russo e americano – è una trasformazione della pratica comunista, in
Russia e nei paesi satellite. Non sappiamo qual è il margine delle
variazioni che questa pratica comporta. Noi sappiamo che un regime
sovietico non è più invulnerabile di qualunque altro alle ripercussioni
dello sviluppo economico, alle emozioni e ai sogni degli uomini, alle
influenze venute dall’esterno e soprattutto dall’Occidente. Per giunta,
questo regime è colpito da una breccia interna, ignorata dai dispotismi
orientali del passato, è condannato dall’ideologia cui si richiama.
La rivoluzione ungherese segna una tappa decisiva in questa condanna del
sovietismo da parte dell’idea socialista. I suoi attori sono morti,
esiliati o ridotti all’impotenza: la loro azione sopravvive alla loro
disgrazia, il loro esempio continua a risplendere. La nazione ungherese
si è sacrificata per una causa che la superava, per quanto grande fosse
la causa della libertà di un piccolo popolo. Operai, intellettuali,
studenti, uniti secondo il sogno di Marx, insieme hanno dimostrato che
il regime totalitario, pretendendo di sopprimere le rivalità, legittime
e feconde, degli uomini e delle idee, forgia l’unanimità del popolo
contro l’apparato della tirannia.
Quale che sia l’avvenire, per quanto a lungo si debba aspettare il
giorno in cui gli ungheresi celebreranno la loro rivoluzione d’Ottobre,
esiste una vittoria dei vinti che nessun episodio della storia potrebbe
cancellare. La politica non è la realtà suprema e gli avvenimenti
dipendono anche da un altro tribunale. In termini di saggezza pratica,
una riforma riuscita sarebbe stata preferibile a una rivoluzione
schiacciata, ma il sacrificio dei giusti, il rifiuto della
sottomissione, l’acconsentire alla morte proclamano una verità la cui
forza silenziosa, alla lunga, ha la meglio sulla violenza delle armi e
la gloria equivoca dei conquistatori. La follia degli ungheresi, in
rivolta da soli contro un impero onnipotente, continuerà di secolo in
secolo a testimoniare per l’uomo e a dare fede nel suo destino.
Note
1. Parlo dell’Europa. Accade lo stesso in Cina? In
mancanza di conoscenze, preferisco astenermi da ogni presa di posizione
su questo punto.
2. Durante la guerra, a Londra, nulla colpiva di più che il contrasto
tra l’atteggiamento dei cechi e quello dei polacchi nei confronti dei
russi. I primi cercavano la salvezza nelle concessioni e
nell’opportunismo, i secondi nella resistenza. Probabilmente i cechi
avrebbero evitato la sovietizzazione se avessero adottato
l’atteggiamento dei polacchi o dei finlandesi.
3. Per quanto io ne sappia, questa radio, che commise delle imprudenze,
non chiamò gli ungheresi a prendere le armi e non promise un aiuto
armato dall’Occidente.
4. Va da sé che i provocatori svolgono un ruolo da una parte e
dall’altra, ma gli “agenti dell’imperialismo” nulla potrebbero contro un
regime socialista poggiante sulla massa del popolo.
5. Che ci siano stati degli eccessi, che i membri della polizia politica
siano stati linciati, nessuno lo nega e i rivoluzionari stessi se ne
dolgono. Ma, come scrive il professor Seton–Watson, il numero delle
vittime, secondo un giornale polacco, ammontava a un’ottantina. Non
conviene a coloro che esaltano gli avvenimenti del 1917 di trarre
argomento dalle vendette popolari, inevitabili e comprensibili quanto
deplorevoli.
(Traduzione di Federigo Argentieri)
03 ottobre 2006
* Raymond Aron è stato uno dei maggiori
intellettuali europei del Ventesimo secolo
|