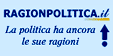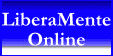|
Margaret Thatcher: perché
ne parliamo ancora
di Cristina Missiroli
da Ideazione di luglio-agosto 2006
Se gli anni Sessanta furono gli anni dei Beatles, gli anni Ottanta sono
stati per la Gran Bretagna gli anni di Margaret Thatcher. La Signora di
Ferro ha lasciato un’impronta indelebile, come i ragazzi di Liverpool.
Nulla è più stato uguale. Senza di lei Tony Blair e il suo New Labour
non sarebbero mai esistiti. E se Silvio Berlusconi avesse davvero fatto
come lei, oggi, forse, non avremmo Romano Prodi e il suo governo
vetero-sinistro a Palazzo Chigi.
La rivoluzione thatcheriana ebbe successo non solo perché fu combattuta
al momento giusto. Ma anche perché la Signora ci credette dall’inizio e
fino in fondo. Quindici anni più tardi, Alistair McAlpine, suo
consigliere, scrisse un libello dal titolo The Servant, oggi
introvabile, tradotto da Mondadori col titolo Il nuovo Machiavelli. Quel
volumetto spiega bene il rapporto che, nella mente di chi lavorò al
fianco della Thatcher, esiste e deve esistere tra il Principe e l’Idea.
«L’Idea è il pensiero filosofico che sta alla base di tutte le azioni
del Principe. Da quest’ultima il Principe trae la propria forza. Il
Principe ha bisogno dell’Idea allo scopo di prendere via via le
decisioni necessarie per l’acquisizione durevole del dominio sul
territorio. Sottraete al Principe l’Idea, e di lui non resterà più
nulla».
È il rapporto privilegiato e fortissimo con l’Idea ciò che caratterizza
l’intera avventura governativa della Thatcher. È per questo che, prima
tra i politici di professione, è stata scelta per il Feuilleton di
Ideazione. Diceva: «In politica, se vuoi un bel discorso chiedilo ad un
uomo; se vuoi i fatti chiedili ad una donna». Ma diceva anche: «Perché
scalare le vette della filosofia? Perché ne vale la pena». Senza teoria,
la prassi politica diventa galleggiamento. Diventa qualcosa
d’incomprensibile e non finalizzato. Un po’ come accadeva in Italia.
Scrive la Thatcher a proposito di Giulio Andreotti nella sua
autobiografia: «Questo membro apparentemente indispensabile di tutti i
governi italiani rappresentava una linea politica che non potevo
condividere. Sembrava avesse una reale avversione per i principi, anzi
la profonda convinzione che un uomo di principi fosse condannato ad
essere ridicolo». Il legame strettissimo tra teoria e prassi, il
contatto costante con i think tank che elaborarono la base teorica della
sua azione, rende perciò la Thatcher un politico-filosofo. Come Ronald
Reagan, ad esempio. E molti altri a cui la nostra rivista dedicherà, in
un futuro prossimo, queste stesse pagine, destinate fino ad oggi
prevalentemente a maestri del pensiero.
Un ciclone sul paese e sul sistema dei partiti
Forse un po’ ce lo siamo dimenticati, ma nel 1979 la signora Thatcher è
piombata sulla Gran Bretagna come un terremoto. E con pari delicatezza
ha squassato la nazione, annunciando quel che nessuno aveva mai osato
prima. Che l’Inghilterra aveva vinto la guerra ma era come se l’avesse
perduta. Che dal 1945, proprio quando i guai sembravano finiti, aveva
smesso di essere una grande potenza. Che aveva perso l’impero. Che
doveva scegliere di diventare qualcos’altro.
Con tutta la ruvidezza per la quale poi è diventata proverbiale, la Lady
di Ferro ha costretto il paese a guardare in faccia la realtà. Come
spesso accade, l’inizio del rinascimento coincise con il punto più basso
toccato dalla nazione. Era l’inverno tra il 1978 e il 1979. A causa
degli scioperi, i morti rimanevano insepolti e l’elettricità era
razionata. Gli inglesi, con il morale sotto le scarpe, erano pronti alla
svolta. Margaret Thatcher fiutò il vento che cambiava e rivelò la sua
ricetta: iniziativa economica individuale, rispetto delle leggi,
orgoglio nazionale, disciplina individuale, ordine. Erano i valori della
classe media da cui proveniva. Presto sarebbero stati i valori
nazionali. Quei valori la portarono, prima donna nella storia
britannica, al numero 10 di Downing Street. Là sarebbe rimasta fino al
1990.
Quando la Thatcher raccolse il governo inglese, il paese era allo
stremo, la stampa definiva la Gran Bretagna il “grande malato d’Europa”.
Con la forza dell’Idea, la Signora inventò la sua rivoluzione. Durante
la recessione del 1980-1982, si rifiutò di seguire la teoria economica
keynesiana, allora dominante, che imponeva di stimolare la domanda.
Invece prese di petto la spesa pubblica, l’inflazione, i sindacati.
L’accusarono di aver inferto all’Inghilterra un bagno di sangue. Contro
tutto e tutti ingaggiò uno storico braccio di ferro con i sindacati
durante lo sciopero dei minatori. Alla fine vinse, tirandosi dietro
l’odio (che perdura tuttora) della sinistra mondiale. E mentre gli
intellettuali e i laburisti sbraitavano, la Thatcher cominciò a scuotere
le coscienze degli inglesi. Invece di farsi intimorire dalla campagna
stampa e dall’ostracismo dell’intellighenzia, spiegò che «aver pensato
di curare l’Inghilterra col socialismo era come aver tentato di curare
la leucemia con le sanguisughe». Che per ridistribuire ricchezza occorre
prima produrla. Che questo non era compito dello Stato ma degli
individui. Perciò lo Stato si sarebbe fatto da parte e avrebbe lasciato
ai cittadini spazio, responsabilità, decisioni. Perciò lo Stato avrebbe
venduto aziende e privatizzato i servizi non essenziali, privilegiando
l’azionariato diffuso e incoraggiando il risparmio della classe media.
La Thatcher abolì il controllo sui movimenti di capitale, ridusse le
imposte sulle società, tenne costante il valore della sterlina,
utilizzando anche impietosamente l’arma dei tassi d’interesse. Fino a
che la deregulation non attirò decine di istituzioni finanziarie
straniere a Londra e molte sterline nelle tasche di giovani
intermediatori inglesi e l’Europa, con il suo mercato unico, divenne un
enorme supermercato per i servizi finanziari britannici. Per la gioia
dei grandi investitori della City. Ma non solo. In quegli stessi anni,
gli operai impararono che voler comprare una casa non è un’infamia, ma
piuttosto una scelta di dignità e buon senso. E gli inglesi impararono
che aver battuto i nazisti per poi farsi sconfiggere dai sindacati non
solo era folle, era ridicolo.
Travolti da un ciclone del genere, gli avversari della Signora non si
sono mai del tutto ripresi. I laburisti per primi. Appena cominciarono a
capire vagamente ciò che stava accadendo, si resero conto con orrore che
la Thatcher non si sarebbe accontentata di inseguirli di sconfitta in
sconfitta. Intendeva convertirli. Guardare Blair per credere. Anche gli
amici, però, non si sono più ripresi. Quando i conservatori capirono a
chi avevano affidato le redini del partito era ormai troppo tardi per
tornare indietro. A nulla serviva rimpiangere Disraeli e il suo
conservatorismo caritatevole: il partito Tory, come lo avevano
conosciuto fino ad allora, era sparito per sempre. Sotto la guida della
figlia del droghiere di Grantham, il partito conservatore trascese i
limiti della upper class che l’aveva prodotto: cercò voti ovunque, anche
nelle classi borghesi o lavoratrici. E, quel che apparve più
sorprendente, li trovò. Per i Tory era una folgorazione, per i laburisti
uno shock. Perché alla fine degli anni Settanta tutti i partiti inglesi
si professavano, in pubblico, interclassisti. Ma non era vero. Non
ancora. La working class votava per il Labour, gli intellettuali
brontoloni si dividevano tra liberali e social-democratici. E le élite
tradizionali votavano conservatore.
La rivoluzione thatcheriana spazzò via certezze e steccati. I
conservatori cambiarono linguaggio, stile, regole. Con orrore di qualche
Lord, apparvero candidati che assomigliavano a venditori di macchine
usate. Che parlavano come venditori di macchine usate. Che si
rivolgevano a cittadini che compravano macchine usate. Ad ascoltarli,
nei comizi di periferia, arrivarono altri inglesi, alla guida di
macchine usate. Quegli stessi inglesi, dopo la cura Thatcher, sarebbero
diventati proprietari di casa, riscattando la propria abitazione grazie
ad una legge del governo conservatore. Certo, i vecchi Tory storcevano
il naso, dicevano di detestare quell’insopportabile signora, con la sua
aria da signorina Rottermeier. Per lei, i suoi stessi compagni di
partito, coniarono una serie infinita di appellativi e nomignoli, da
usare nelle conversazioni maschili al club, tra un sigaro e un whisky.
Finirono addirittura a chiamarla per sigle, necessarie – dicevano – per
semplificare il discorso, data la frequenza con cui le imprecazioni
ricorrevano nei dibattiti. La chiamavano “Tina”, che sta per There is no
alternative, non c’è alternativa. Oppure “Tbw”, That bloody woman,
quella maledetta donna. Però, in fondo al cuore, l’amavano
profondamente. Come i nobili d’un tempo amavano il proprio fattore:
poteva non essere simpatico, ma era indispensabile per amministrare con
frutto le tenute.
Venerata, ammirata, temuta, Margaret Thatcher non è mai stata, però, del
tutto accettata dall’opinione pubblica britannica. Colpa dell’immagine
di donna rigida e perfetta, senza cedimenti umani o pigrizie inglesi.
Rigorosa anche nei casi in cui la sua politica finì per essere meno
drastica nei fatti che nelle parole. Come nella riduzione della spesa
pubblica. Lo sapeva. E si consolava dicendo: «Coloro che sono fatti per
piacere sono portati naturalmente al compromesso. E non raggiungeranno
gli scopi che si prefiggono». E ancora: «Essere un primo ministro è un
lavoro solitario. Non si può governare stando in mezzo alla folla».
Quando nel 1990 fu costretta a lasciare il governo e la guida del
partito, fu soprattutto perché ormai gli inglesi avevano ritrovato la
dignità, la voglia di primeggiare, di lottare. Ma dopo tutto quello
sforzo, avevano probabilmente voglia di rilassarsi, di cedere alla
pigrizia inglese e di affidarsi di nuovo alle cure dello Stato. Almeno
un po’.
Reagan e Thatcher: la strana coppia
Il 1979, quando la Thatcher arrivò al governo, non era un anno buio solo
per la Gran Bretagna. Era il tempo della seconda crisi petrolifera,
della rivoluzione iraniana, dell’invasione sovietica dell’Afghanistan.
La guerra fredda era al culmine, i sovietici piazzavano i loro missili
contro le democrazie libere. Con tanti guai in patria, la Thatcher
avrebbe dovuto prepararsi a gestire anche delicate crisi internazionali.
Le avrebbe quasi sempre gestite in prima persona. Guardando con sospetto
i ministri degli Esteri, fedele al radicato pregiudizio inglese che
deriva da questo bislacco ragionamento: se il ministro dell’Agricoltura
fa gli interessi degli agricoltori, il ministro degli Affari Esteri che
fa, se non gli interessi degli Stati stranieri? Nella Thatcher questo
sospetto sopravvisse, all’ennesima potenza. Tutti i collaboratori che si
occupavano di politica estera furono accusati a turno, almeno una volta,
di essere troppo morbidi, troppo trattativisti, poco meno che traditori.
I sospetti maggiori, come è noto, la Lady di Ferro li concentrava sul
processo di unificazione europea così come si andava sviluppando in
quegli anni. Non le piacevano neppure gli uomini che la stavano
costruendo. Non le piacevano gli italiani, troppo infidi. Non le
piacevano i tedeschi, troppo pericolosi. Non le piaceva neppure Giscard
d’Estaing che pure era di destra, troppo burocratico e freddo. Eppure la
sua analisi, fredda e lucida, andrebbe riletta oggi. Soprattutto
dovrebbero rileggerla gli euroentusiasti, per riconoscerle, almeno col
senno di poi, una qualche ragione. Eppoi, altro che Europa. La Thatcher
aveva da occuparsi dell’Impero. L’Impero che era perduto, ma che sotto
la sua guida non fu abbandonato. Ancora oggi le ex colonie formano una
rete invidiabile. Non solo commerciale, ma anche politica. Non esiste
presidente o sovrano di uno qualsiasi degli staterelli del Commonwealth
che non abbia in ufficio la foto con la regina a Buckingham Palace. Il
nuovo ruolo internazionale è stato costruito, inventato, preservato. Non
subìto. Se ne accorsero a loro spese gli argentini, rigettati duramente
nelle acque delle Falkland che avevano osato occupare.
Ma nel 1979, la Thatcher ancora non sapeva che avrebbe avuto presto un
partner fidato, che l’avrebbe accompagnata per otto degli undici anni
del suo mandato. Pochi mesi dopo il suo avvento al numero 10 di Downing
Street, infatti, gli americani mandarono alla Casa Bianca l’ex attore
Ronald Reagan. Molti anni dopo, la Thatcher scriverà: «Ricordo ancora
vividamente il sentimento che provai quando seppi dell’elezione del
presidente Reagan. Ci eravamo incontrati e avevamo discusso le nostre
idee politiche alcuni anni prima, quando era ancora governatore della
California. Seppi subito che insieme avremmo potuto affrontare il
compito che avevamo di fronte: rimettere in piedi i nostri paesi,
restituire orgoglio e valori, fare del nostro meglio per creare un mondo
migliore e più sicuro». Così sarebbe stato. E non è un caso se il
momento più toccante della cerimonia funebre di Reagan rimarrà per
sempre il saluto della sua amica Maggie di fronte alla bara. Ancora oggi
i nomi della Signora e dell’Attore sono sempre accomunati. Come maestri
della rivoluzione liberale, da chi ancora li ammira e li studia. Come
affamatori del popolo in nome del capitalismo e del liberismo, da chi
ancora sogna Fidel Castro e Che Guevara. Eppure la loro fu una relazione
complicata e tempestosa. Li accomunava la convinzione comune della
superiorità morale (sì, proprio morale) delle società fondate sulla
libera impresa e l’imperativo che ne seguiva: combattere a livello
internazionale la minaccia del comunismo sovietico.
C’era anche di più: i due, quando s’incontravano si divertivano insieme,
erano diventati amici e godevano della compagnia reciproca. Reagan
ammirava la Thatcher per il suo equilibrio e la sua intelligenza
d’acciaio. La Lady di Ferro era affascinata dall’umorismo del presidente
americano e dalle maniere gentili. Eppure non potevano essere più
diversi: per carattere e modo di lavorare. Lei grande accentratrice, lui
abilissimo nel delegare. Lei sempre al chiodo senza perdere una battuta,
dormendo al massimo quattro ore per notte e soffrendo come un cane
quando le vacanze di qualche collaboratore inceppavano la sua
efficientissima organizzazione giornaliera. Lui caparbiamente fedele
alla sua illustre battuta: «È vero che il lavoro duro non ha mai ucciso
nessuno. Ma perché correre il rischio?». Lei tutta immersa in una
visione dura, oscura e negativa della natura umana. Lui inguaribile
ottimista, con l’allergia dichiarata per il pessimismo che guastava gli
animi e l’economia. Con un approccio tanto diverso, nessuno stupore che,
più di una volta, tra i due si sia giunti a momenti di enorme tensione.
Lo scontro più violento ci fu all’epoca della guerra nelle Falkland. Il
dittatore argentino non aveva capito chi aveva di fronte e,
impadronendosi delle isole sotto il dominio britannico, scatenò le ire
della Thatcher e la guerra che ne seguì. L’Inghilterra fece da sé e
vinse. Ma la Lady di Ferro si aspettava dall’alleato un aiuto, invece la
Casa Bianca si offrì al massimo di negoziare. Lei uscì dai gangheri, lo
prese come un tradimento e glielo fece sapere. Eppure nemmeno in
quell’occasione la Signora riuscì a tenergli il broncio troppo a lungo.
Un affare molto più serio fu, invece, quello del 1986. Quanto toccò alla
Thatcher riportare Reagan con i piedi per terra. Nell’incontro di
Reykjavik il presidente americano sembrava sul punto di accettare la
proposta di Mikhail Gorbaciov di far piazza pulita di tutte le armi
nucleari. La Lady di Ferro pensò che il suo amico fosse uscito di senno.
Certo, era stata lei a convincerlo che Mr. Gorbaciov era un uomo con cui
si potevano fare affari. Per il leader russo, la Signora avrebbe sempre
mantenuto una certa passione. Ma l’accordo che si preparava a Reykjavik
non solo era assurdo: era pericoloso. Le armi nucleari ormai esistevano
e non si poteva far finta di non averle inventate. E, soprattutto,
quelle armi americane avevano mantenuto la pace in Europa, evitando che
l’urss facesse valere la propria supremazia. Per la Thatcher c’era il
grave pericolo che Reagan cadesse nella trappola sovietica. Bastò un
incontro a Camp David per riportarlo sulla retta via del dialogo senza
cedimenti. Grazie a questa strategia, scriverà la Thatcher dopo la
caduta del muro di Berlino, «Mr. Reagan ha vinto la guerra fredda senza
sparare un colpo». Malgrado questi battibecchi, i due, insieme,
segnarono quegli anni e gli anni a venire. Ed è facile capire il perché
di tanta sintonia di fondo. Reagan e Thatcher erano entrambi outsiders
della vita politica del loro tempo: due inguaribili ottimisti,
inizialmente sbeffeggiati e trattati con sufficienza dall’establishment
dei loro stessi partiti, ancora affogati nel vecchio conservatorismo
pessimista e nostalgico dei tempi andati. Trovarono conforto l’uno
nell’altra, s’incoraggiarono nei momenti più difficili, avvalorarono a
vicenda le loro tesi e azioni politiche, in patria e all’estero. La loro
rivoluzione parallela sarebbe stata più difficile se condotta in
solitario.
13 luglio 2006
|