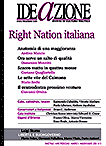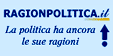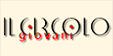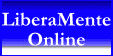|
Sturzo, la modernità di un parroco siciliano
di Flavio Felice
da Ideazione di maggio-giugno 2006
«Se Sturzo fosse vivo oggi avrebbe centoventicinque anni», con queste
parole un noto intellettuale cattolico ed autorevole storico del
cattolicesimo democratico iniziò il suo intervento ad un convegno del
1996 che intendeva celebrare don Luigi Sturzo a centoventicinque anni
dalla nascita. La sentenza di morte del pensiero sturziano appare fin
troppo evidente dalle parole dell’autorevole studioso. Invero, una
simile sentenza è più che legittima e potremmo persino riconoscerle una
qualche utilità – quanto meno a frenare inopportuni ed opportunistici
apparentamenti – se non fosse altro che essa appare tutt’altro che
originale, ma già scritta ai tempi in cui Sturzo fondava il Partito
Popolare. Proprio così, sembrerebbe quasi che il messaggio sturziano sia
nato vecchio, o almeno tale sembrò a molti quando, nel 1919, da un
albergo al centro di Roma, il prete siciliano si appellò «a tutti gli
uomini liberi e forti», in un’epoca in cui si faceva strada l’idea che
tutto dovesse ridursi allo Stato onnipotente. Continuò ad apparire
vecchio durante gli anni del regime fascista e del suo lungo esislio, un
esilio che durò ben 22 anni. Ma ancor più vetuste apparvero le idee di
Sturzo quando, nel 1946, fece ritorno in Italia. Lui, che suo malgrado
aveva conosciuto una delle più grandi, antiche e – all’epoca – poche
democrazie della terra, torna in Italia con l’ansia tipica dell’esule e
rimane letteralmente atterrito dal grado di fascistizzazione di cui sono
stati vittima il suo paese e tanti dei suoi vecchi amici popolari.
Dunque, non è una novità che a qualcuno quel pensiero sia apparso ed
appaia anche oggi non adatto ai tempi ed è legittimo sostenere che una
parte consistente della cultura politica cattolica abbia poco o nulla a
che fare con il popolarismo sturziano. Ad ogni modo, quali sono i punti
che caratterizzano il pensiero di Sturzo – il suo cattolicesimo liberale
– e che da sempre suonano così “fuori stagione”? Sturzo è figlio del suo
tempo, e del suo tempo visse le dispute più significative. Sturzo si
oppose decisamente tanto alla “pan-sociologia” comtiana, quanto
all’organicismo durkheimiano, tanto all’idealismo hegeliano quanto al
materialismo storico marxiano, mentre tentò di sviluppare – certo in un
modo originale – il principio di avalutatività rispetto ai valori di
matrice weberiana. I punti sensibili del suo percorso intellettuale
possono essere espressi nei seguenti quattro principi: la centralità
della persona, la libertà integrale ed indivisibile, l’antiperfettismo
sociale e la soggettività creativa. Rispetto alla centralità della
persona, Sturzo è inequivocabile sotto il profilo ontologico,
metodologico e politico: «L’unico vero agente della società è l’uomo
individuo in quanto associato con altri uomini a scopi determinati». In
secondo luogo, la libertà di cui gode la persona non può che essere una
libertà integrale ed indivisibile, in tal senso Sturzo entrò nel vivo
della disputa su liberismo-liberalismo: «Se la libertà è violata in
campo economico, è lesa anche, secondo me, in quello culturale, in
quello politico e sociale e viceversa. Non c’è esempio nella storia di
una libertà che stia insieme da sola».
Riguardo all’antiperfettismo sociale, per Sturzo non esistono società
perfette, poiché tutte presentano i limiti che contraddistinguono la
costituzione fisica e morale della persona. Infine, per Sturzo la
soggettività creativa, in forza della quale gli individui cooperano per
rispondere ad una vocazione universale, li spingerà a dar vita ad
istituzioni politiche, economiche e culturali nelle quali potersi
realizzare. I quattro principi disegnano un programma intellettuale e
politico di matrice liberale, un liberalismo che Sturzo esprimerà in
ambito economico battendosi con forza contro le cosiddette tre «male
bestie»: la partitocrazia, lo statalismo e lo sperpero del denaro
pubblico: «Infatti dopo gli ammassi, i miliardi dell’inam, i deficit
della cinematografia, vengono pretenziose le iniziative eni, che pompano
il denaro pubblico […]; così noi possiamo registrare uno Stato non solo
“non sociale” ma “antisociale”, che disgrega, dissipa, disfa tutto
quello che pensa di promuovere a vantaggio del popolo».
La risposta di Sturzo è incentrata sul ruolo attivo delle comunità
intermedie; lo statalismo si combatte facendo emergere dal basso le
forze vive della nazione. È questo il senso più profondo anche
dell’autonomismo sturziano. Il federalismo sturziano, di conseguenza,
non è una semplice devoluzione dei poteri dal “centro” verso altri
“centri” minori. Non che ciò non sia utile e, nel caso italiano,
evidentemente indispensabile, ma Sturzo lo giudicherebbe ancora
insufficiente: si corre il rischio che ad un centralismo si risponda con
tanti piccoli centralismi. Il suo federalismo sgorga dal principio di
sussidiarietà orizzontale e si propone di risolvere le difficoltà create
dalla centralizzazione illiberale del potere dello Stato attraverso il
ruolo attivo dei soggetti che compongono la società civile. Infine, il
federalismo di Sturzo è proiettato verso la dimensione europea senza
disconoscere il valore dell’identità nazionale: «Solo attraverso le
autonomie locali si prepara una vita nazionale sempre più viva e
coerente e una coesione internazionale sempre più effettiva e sentita».
Credo che nessuno onestamente possa dire che cosa Sturzo avrebbe pensato
oggi della devolution, di sicuro non avrebbe urlato alla dissolution
nazionale, ma non avrebbe neppure brindato alla vittoria. Si sarebbe
battuto come un leone per migliorare la riforma, e in ogni caso non
l’avrebbe gettata tutta al macero. Disgraziatamente però dobbiamo
ammettere che Sturzo non ha eredi né nell’accademia né nella politica,
nella sua lunga vita ha avuto molti nemici, ha sofferto il dileggio e
l’emarginazione di coloro che lui chiamava i “sinistri dc” e la generale
indifferenza dei cattolici. Il contributo di Sturzo allo sviluppo delle
scienze sociali è ampio e complesso e con queste righe introduttive chi
scrive non pretende di aver esaurito gli elementi sensibili e gli
argomenti rilevanti; restano aperti altri problemi. Tuttavia, l’augurio
è che il sommario quadro concettuale appena esposto possa consentire al
lettore di assumere criticamente i contributi che seguono, con la
consapevolezza della immensa ricchezza scientifica e morale dalla quale
provengono.
In conclusione, colgo l’occasione per ringraziare il Rettore della
Pontificia Università Lateranense, S.E. Mons. Prof. Rino Fisichella, ed
il Preside dell’Istituto Pastorale Redemptor Hominis della medesima
Università, il Prof. Denis Biju-Duval, nonché il dott. Giovanni
Palladino, Presidente del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, per
aver reso possibile la realizzazione della serie di conferenze su
“L’opera di Luigi Sturzo nelle Scienze Sociali”, tenutesi presso
l’Istituto Redemptor Hominis durante l’Anno Accademico 2004/2005, che
“Ideazione” ha avuto la cortesia (e l’intelligenza) di proporre (in
parte) nel presente numero della rivista. Un ringraziamento speciale va
ai relatori (D. Antiseri, G. Morra, E. Guccione, U. Chiaramonte, S.E.
Mons. M. Pennini, M. Vitale, R. Pezzimenti) che hanno generosamente
risposto all’invito degli organizzatori ed acconsentito alla
pubblicazione dei loro interventi.
09 maggio 2006
|