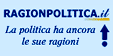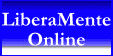|
Alla riscoperta del liberalismo
realista
di
Daniele Sfregola
[09 nov 06]
“Nello
splendido “Lo scopo della politica americana”, Hans Morgenthau
si pone retoricamente il seguente quesito: “La libertà
individuale è più importante della sicurezza nazionale, senza la
quale non ci sarà affatto libertà?”. Non si tratta di un
esercizio accademico. Il tema rappresenta, probabilmente, il
vulnus storico della filosofia liberale. Questo perché lo “stato
di guerra” è per definizione una minaccia per la libertà
individuale. Eppure, insieme al commercio, la guerra è la più
antica e la principale delle interazioni fra gruppi distinti di
esseri umani.
La “comunità internazionale” – formula impropria con la quale si
intende il complesso degli Stati che definiscono il sistema
internazionale – è strutturalmente anarchica. E’, cioè, una
comunità di coordinamento, non di subordinazione. Essa è priva
di un’autorità centrale dotata di poteri coercitivi di tipo
verticale e di organi periferici istituzionalmente preposti a
subirli. Al contrario, questa nasce e si realizza esclusivamente
nei termini di una pluralità di Stati sovrani ed indipendenti,
che nulla riconoscono al di sopra di essi e che in ragione di
questo motivo partecipano di tale sistema.
Quello che Hobbes e Rousseau definiscono “stato di guerra” è
quindi conseguenza di siffatta anarchia strutturale: il pericolo
che l’assenza di un soggetto dirimente le controversie tra Stati
porti allo scoppio di conflitti influenza i governi, li obbliga
a moltiplicare il loro peso interno e quindi a ridurre la sfera
d’autonomia privata riconosciuta in capo ai singoli individui.
Questo tipo di speculazione è tuttavia insufficiente, perché si
limita ad analizzare la dinamica interna agli Stati dovuta allo
“stato di guerra”. La dinamica delle relazioni tra Stati
continua a rappresentare un tema marginale nella biblioteca
liberale. Lo ammise, a suo tempo, Raymond Aron quando, in sede
di recensione de “The Constitution of Liberty” di Friedrich von
Hayek, affermò a chiare lettere che - “come la maggior parte dei
liberali” – il grande Hayek snobbava la politica estera. Ma
questo, in termini di rigore, costituiva un grave limite alla
stessa teoria austriaca della libertà garantita dalle leggi. Per
sua natura, la politica estera è il dominio degli uomini, della
discrezionalità politica, di una irredimibile gradazione
arbitraria – l’arte diplomatica - del tutto sottratta alla legge
hayekiana.
Il denominatore comune alla tradizione liberale è il timore
degli effetti della politica internazionale sulla libertà
negativa. Ma ad una tale, logica avversione non è seguita una
risposta univoca. Il liberalismo classico scelse, in coerenza
con le fondamenta del pensiero di libertà di cui era portatore,
la soluzione realista – nel senso di realismo politico. Ma, a
partire dal XIX secolo, l’elevazione della “domestic analogy” a
criterio-guida della timida speculazione internazionalista
liberale comportò dapprima l’emergere e in seguito il prevalere
di una interpretazione idealista dell’antinomia potenziale tra
libertà e sicurezza. A grandi linee, la distinzione regge ancora
oggi e ruota attorno alla possibilità di trasformazione del
sistema internazionale mediante l’analogia domestica dei Paesi
che hanno sperimentato con successo il modello
liberaldemocratico – democrazia, libertà, pace sociale, legge.
Come spiega Angelo Panebianco nel suo “Il potere, lo stato, la
libertà”, il filone realista sostanzia l’origine del pensiero
liberale, ma col tempo viene dimenticato e sostituito con un
orientamento più militante ed idealista. Ma il fatto che
dall’Ottocento sia divenuto predominante quest’ultimo filone,
non significa di certo che quello minoritario si sia nel
frattempo allontanato dalla dottrina liberale. In termini
concettuali, è piuttosto vero il contrario.
I padri del liberalismo – tra i quali Locke, Hobbes e Hume, e
poi ancora Montesquieu, gli autori del “Federalist”,
Tocqueville, Adam Smith e altri ancora – risolsero il dilemma
prescrittivo predetto in senso realista. Essi concepirono la
politica internazionale come il regno in cui si esercita il
“potere federativo”, ossa il potere puro, non subordinabile alla
legge, in considerazione del suo carattere anarchico. Tale
potere è chiamato a decidere sulle alleanze, sulla pace, sulla
guerra e, come tale, è quindi legato al “variare delle
intenzioni e degli interessi” e “dev’esser lasciato in gran
parte alla prudenza di coloro a cui si è affidato […] secondo il
meglio della loro abilità, per il vantaggio della società
politica” (Locke, 1690).
Hume fu profondamente influenzato dagli insegnamenti di
Machiavelli nei rapporti tra Stati e difese filosoficamente la
pratica dell’equilibrio delle forze perché necessaria nei
sistemi in cui coesistono plurime unità politiche indipendenti,
in coerenza con i limiti di potere auspicabili all’interno di
una società libera. Ma Hume andò anche oltre, dando vita alla
più coerente sintesi tra libertà individuale, società libera e
sicurezza anarchica internazionale. Egli infatti teorizzò la
necessità dell’anarchia internazionale, della politica di
potenza e della “balance of power” ai fini della nascita di
governi liberi. Per Hume la Grecia classica, l’Italia
rinascimentale e l’Europa settecentesca – i soli esempi di un
certo grado di libertà individuale raggiunta dall’uomo nel corso
della storia, al momento in cui egli era in vita - dimostrano
che i governi liberi sanno insediarsi solo dove agiscono una
pluralità di Stati “indipendenti e vicini, collegati dal
commercio e dalla politica” (Hume, 1742-1752). Il liberalismo
classico di Hume, come quello di Adam Smith, diventa liberalismo
realista negli affari internazionali, per spirito di empirismo e
coerenza filosofica.
Del Montesquieu che studia le relazioni internazionali è nota
soprattutto la tesi del “doux commerce”: i commerci
ingentiliscono usi e costumi e pacificano le relazioni tra gli
Stati. Eppure, in realtà, Montesquieu è un altro maestro del
realismo liberale. Egli ritiene che “societas” e “stato di
guerra” coincidano (“Esprit des lois”, Libro I), condivide
l’idea di Hume sull’equilibrio delle forze e infine teorizza la
“società delle società”, ossia quella “repubblica federativa”
che, “capace di resistere alle potenze straniere, può mantenersi
nella sua grandezza senza corrompersi all’interno” (Libro IX).
Queste idee influenzeranno enormemente gli autori del
“Federalist” e quindi le sorti dell’Unione americana. Scrisse
Hamilton: “Se dobbiamo giudicare da quella che è la storia
dell’umanità, dobbiamo concludere che la passione fiera e
distruttrice della guerra regna negli animi degli uomini in modo
assai più potente di quanto non avvenga per i miti e benefici
sentimenti di pace” (The Federalist, n. 34, p. 337). Hamilton
seppe anche speculare relativisticamente sulla capacità della
geopolitica di influenzare in modo significativo il corso delle
vicende di una nazione e la condotta pragmatica degli affari
esteri da parte del suo governo.
Tocqueville scrisse della difficoltà delle democrazie dinanzi
alla conduzione della politica estera, analizzò con insuperata
preveggenza le conseguenze nefaste della guerra sul peso dei
governi nella vita politica e sociale interna e auspicò quale
più efficace dei rimedi la creazione di un esercito potente e
capace di dissuadere gli agenti esterni.
Il liberalismo ottocentesco, tuttavia, mise da parte queste
idee, che pure in combutta con le dirigenze conservatrici
dell’epoca aveva generato un capolavoro diplomatico quale il
Concerto Europeo, che garantì sessant’anni di pace al vecchio
continente. Intimoriti dallo “stato di guerra” derivante
dall’anarchia internazionale, la seconda generazione di grandi
liberali condannò senza appello la pratica dell’equilibrio delle
forze ancor prima che questo desse segni di cedimento in virtù
di un approccio millenaristico anziché storico, la “nuova èra
liberale”. Persuasi che la soluzione al potenziale contrasto tra
la tutela della libertà e la garanzia della sicurezza nazionale
risiedesse nell’eliminazione del carattere anarchico del sistema
internazionale, i più importanti esponenti del pensiero liberale
di quel secolo si affaticarono nella congettura di strategie
finalizzate a modificare costruttivamente la natura del mondo.
Sorsero teorie che ebbero largo seguito, che influenzarono lo
sviluppo dell’intero pensiero liberale nei decenni a seguire e
che, nonostante i ciclici fallimenti, continuano a persistere
ancor oggi.
Il presupposto è comune a tutte le teorie liberali idealiste: la
“domestic analogy”. Il commercio, la legge, la democrazia
possono cambiare il mondo, pacificarlo e regolarlo mediante
appositi istituti, così come avviene in una democrazia liberale
con le istituzioni sociali interne. Benjamin Constant parlò di
“età del commercio”. Più in generale, quei liberali
estremizzarono la tesi di Montesquieu del “doux commerce” e
attribuirono alla pratica dello scambio di beni tra più Stati
una valenza salvifica. A lungo, per quasi tutto l’Ottocento, si
ritenne che tale idea fosse comprovata dai fatti. Una
moltitudine di pensatori rafforzò questa teoria: Jean Baptiste
Say, Friedrich Bastiat, Herbert Spencer, John Stuart Mill,
Richard Cobden. In realtà, come anticipato, i sessant’anni di
pace – e l’espansione commerciale che si accompagnò - furono
innanzitutto preservati dalla pratica diplomatica della “balance
of power”, il complesso gioco di incentivi e disincentivi di
potenza tra gli Stati accompagnato da un consenso etico
sostanzialmente omogeneo. Prova ne sia la constatazione
storiografica secondo la quale l’èra del Concerto Europeo, e
quindi della pace e del benessere nel vecchio continente, venne
meno con l’emersione destabilizzante al rango di potenza
geopoliticamente decisiva della Prussia bismarckiana, non certo
con repentine restrizioni alla libertà commerciale. Al di là di
ciò, può dirsi con ragionevole certezza che se è vero che il
libero commercio tra Stati tende a favorire un comune interesse
alla preservazione della pace, è altrettanto vero che non
esistono relazioni politico-militari deterministicamente segnate
tra Stati che commerciano fra loro.
La pace democratica e quella della legge accompagneranno, spesso
in modo concettualmente confuso, la teoria della pace
commerciale. La prima, con personaggi come Paine e Bentham, si
affida ad un assioma storicamente inesatto: l’opinione pubblica,
se lasciata libera di influenzare il corso degli eventi
politici, ha una forza pacificatrice e democratizzante capace di
espandersi a macchia d’olio in giro per il globo. L’obiettivo
utopico di un siffatto ragionamento è, col tempo, la
sostituzione delle relazioni diplomatiche – ritenute poco
“democratiche” e trasparenti di per sé – con meccanismi
automatici di risoluzione pacifica delle controversie
internazionali. Aron dimostrò, tuttavia, che il XX secolo
insegna la stupefacente capacità delle società democratiche di
oscillare tra pacifismo ad oltranza e bellicosità istantanea.
Inoltre, sebbene vi sia una certa regolarità empirica
nell’assioma secondo il quale le democrazie non si fanno la
guerra, esistono anche rilevanti eccezioni e, soprattutto, la
correlazione è spuria: per ogni coppia di democrazie
l’eventualità della guerra è statisticamente rara, ma non
assente, e ciò però basta ad inficiare i presupposti teorici
dell’assioma; inoltre, la storia recente non può assurgere a
parametro unico, casomai a semplice indizio, perché il confronto
ideologico della Guerra Fredda ha, di fatto, posto le democrazie
sotto l’ombrello egemonico americano, rendendole, alla bisogna,
“semi-democrazie”, e non democrazie liberali nel senso pieno del
termine.
La tesi della pace della legge trova in Immanuel Kant il suo più
degno assertore. Sebbene quest’ultimo in realtà si sfili
facilmente da classificazioni di maniera e non disdegni affatto
l’approccio realista alle relazioni internazionali - per esempio
ammettendo l’equilibrio delle forze - tuttavia pone a monito
morale di ogni uomo il superamento dello “stato di guerra”
mediante la “pace perpetua” e una unione giuridica – il diritto
cosmopolitico - che, però, nelle intenzioni originali del suo
autore avrebbero dovuto vedere la luce in un futuro indefinito,
a corollario storico di un percorso prettamente ideale.
Nella seconda metà del Novecento, studiosi delle relazioni
internazionali del calibro di Morgenthau, Lippmann, Aron
tentarono, con discreto successo e mediante una certosina opera
di critica strutturale agli assiomi della corrente idealista, di
spostare nuovamente il baricentro della concezione
internazionalista della scuola liberale verso posizioni di
Realpolitik. Ma la fine della Guerra Fredda, l’improvvisa e
tardiva scoperta dei valori del libero mercato da parte delle
migliori menti del progressismo moderato occidentale, l’ondata
culturale di riscoperta del pensiero filosofico in esame
attraverso i suoi più recenti esponenti “mainstream” ha finito
per rinsaldare le fila di chi crede che, fuori dai confini
nazionali, l’interventismo e il costruttivismo istituzionale
siano coerenti con ciò che invece rappresenta il loro esatto
contrario sino al ceppo di frontiera: l’equilibrio
costituzionale di poteri o forze e la libertà d’azione.
La crisi dell’istituzionalismo liberale e della “domestic
analogy”, così impietosamente evidenziata dalla paralisi
iperburocratica dell’Onu e dai danni sistemici
dell’interventismo democratico, è la crisi della corrente
idealista del pensiero liberale applicato alla politica estera.
Il tradizionale dilemma tra la libertà individuale e la
sicurezza nazionale richiede una nuova risposta concettuale.
Alla riscoperta del liberalismo classico in economia, che ha
caratterizzato il decennio passato, oggi converrebbe aggiungere
il recupero di quella pragmatica saggezza fondativa applicata
alle relazioni tra Stati.
daniele.sfregola@epistemes.org
09 novembre 2006
|