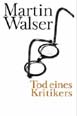| |
Morte
di un critico
di Martin Walser
Sugarco, Milano, 2004
pp. 213, € 16,80
|
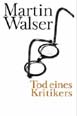 |
Il sacerdote dell’egemonia
di Francesco Galietti
[17 nov 04]
In Italia pochi conoscono Martin Walser, perché la maggior parte
delle sue opere non ha mai avuto un’edizione italiana. «Scrive
libri troppo tedeschi», così venne liquidata la questione da Gian
Enrico Rusconi, uno degli studiosi italiani che più si occupano di
Germania. Il che non sarà forse una frottola tout court, ma
certamente non vale per tutte le opere di Walser. Come il recente
Morte di un critico, edito in Italia da Sugarco, e tradotto da
Francesco Coppellotti. Il romanzo parla di come un terribile
critico letterario, assorto al ruolo di superstar mediatica, André
Ehrl-Koenig, dopo aver condannato in una delle sue apparizioni
l’opera dello scrittore Hans Lach, venga da questi apostrofato
duramente, e, al termine di una serata mondana, non venga più
trovato. Hans Lach viene arrestato subito in quanto superindiziato
per l’omicidio del critico, e tutti gli elementi depongono contro
di lui. Solo Michael Landolf, scrittore esperto di mistica,
cabala, alchimia e Rosacroce, autore di Da Suso a Nietzsche, non
ci vuole credere. Da qui l’inizio del romanzo vero e proprio, che
culmina in un colpo di scena finale di cui non vogliamo privare il
lettore.
D’altronde Martin Walser è uomo abituato a dare scandalo, come
quando nel 1998, in una sua celebre orazione presso la Paulskirche
di Francoforte, dove era stato insignito del premio per la pace
dei librai tedeschi, si scagliò contro il progetto di memoriale
dell’Olocausto a Berlino: una superficie disseminata di lapidi
proprio davanti alla porta di Brandeburgo. «Un incubo grande come
un campo di calcio» fu il commento di Walser.
Da
allora, secondo un costume assai diffuso in Germania oggi, a
Walser venne impropriamente rifilata l’etichetta di antisemita.
L’uscita della Morte di un critico venne accompagnata da vistose
polemiche da parte della FAZ, il principale quotidiano tedesco,
che si rifiutò di pubblicare un’anteprima del libro, giudicato
antisemita. Il che, ovviamente, fece di questo instant book uno
dei libri più venduti in assoluto. Anche in Italia l’establishment
vede in questo libro un inaudito affronto al suo potere: troppo
forti le analogie tra André Ehrl-Koenig, il critico
letterario-superstar del romanzo, e Marcel Reich-Ranicki, il suo
analogo nella vita reale. Reich-Ranicki incarna il Verbo
mediatico, è l’implacabile arbiter elegantiarum che può, egli
solo, argomentare su cosa sia bello e cosa no. Le critiche in
Italia si sono concentrate tutte sulla traduzione di Coppellotti.
Il
tremendo censore dell’Indice, nascosto dietro uno pseudonimo,
rovesciando le solite accuse di antisemitismo non sull’autore ma
sull’interprete e curatore, aggiunge al proprio livore personale
nei confronti di Coppellotti anche dell’altro. Non ci priva
infatti della commovente immagine della maestrina da Libro Cuore,
trasfigurata in versione Erinni feroce, quando taccia l’interprete
di aver scopiazzato alla bell’e meglio ben metà della postfazione
all’edizione italiana da un testo critico tedesco, e, colpa
gravissima, di non trovarsi a suo agio «nelle malizie del discorso
indiretto libero». Quando un romanzo genera una carica di ferocia
tale, non può che trattarsi di un romanzo “importante”, ecco
perché ci pare, in tutta franchezza, che Morte di un critico non
sia per nulla “troppo tedesco”, ma adattissimo agli italici
lettori.
|