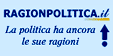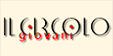|
|
![]()
|
Dubbi legittimi sullo sciopero di Tiziano Buzzacchera* [06 ott 05] Perdonate la nota personale: qualche giorno fa, navigando su Internet, mi è capitato, dando velocemente uno sguardo alle dichiarazioni piovute dopo lo sciopero dei metalmeccanici, di imbattermi in queste parole: “A Torino la Fiom ha rotto l’unità” (firmato, pure le virgolette, Antonino Regazzi, segretario generale della Uilm). Bene: l’unità sindacale s’è rotta (solo a Torino, pazienza). A noi, invece, hanno rotto qualcos’altro (si può dire?). E’ cominciato l’autunno caldo. E quanto ci farebbe piacere che facesse già freddo! La conflittualità (ma è persino ovvio) non giova certo all’economia. Altra banalità: gli scioperi sono tutto fuorché mirati esclusivamente a tutelare i “diritti dei lavoratori”. E’ dubbio anche solo pensare che le tensioni fra rappresentanze sindacali e mondo imprenditoriale possano frenare, fare marcia indietro, arretrare di un passo. Lo sciopero, infatti, è solo un tappeto disteso su un pavimento di sottintesi ideologici. Il datore di lavoro sfrutta il lavoratore, non gli garantisce i giusti diritti. Inoltre, è in una posizione di vantaggio rispetto al prestatore d’opera. Da queste convinzioni sboccia la teoria secondo la quale la sospensione delle prestazioni di lavoro sarebbero un mezzo per riequilibrare le disparità. Addirittura, la nostra Costituzione ha sdoganato la prassi delle astensioni collettive come un “diritto”(art.40). In realtà, gli ostacoli che presenta questa interpretazione, indubbiamente generosa dal punto di vista giuridico, sono molti. Non lo dico io: lo diceva un grande studioso liberale, Bruno Leoni, secondo il quale “qualificare lo sciopero come un diritto significa introdurre un concetto contraddittorio, una specie di monstrum giuridico”. Esso, infatti, è un’astensione dal lavoro in pendenza di contratto e, come tale, “dovrebbe essere, in base ai principi generali dell’ordinamento giuridico, un illecito civile, per l’inadempienza contrattuale in cui si concreta”. Optando per questa soluzione, tuttavia, pur essendo eliminati gli intralci formali, si complicano i problemi sostanziali. Infatti, essa “comporta gravi difficoltà perché introduce nell’ordinamento una contraddizione: mentre da un lato si consacra – nel nostro come negli altri ordinamenti civili – il principio generale che nessuno sia arbitro di liberarsi a piacimento degli obblighi contrattualmente assunti verso terzi, nel particolare caso del contratto di lavoro si rinuncia invece ad applicare tale principio.” Ora, ipotizziamo che il lavoratore possa liberamente astenersi dal lavoro. Benissimo. Tuttavia l’azienda, a questo punto, dovrebbe avere la possibilità di prendere misure adeguate, di instillare qualche provvedimento. Se al datore di lavoro questo non è concesso, allora la negoziazione non è più tale. E’ solo un ricatto, puro e semplice. Un ricatto il cui peso il sindacato ha fatto valere anche a livello politico, negli ultimi decenni, confermando implacabilmente un’azzeccata e puntuale previsione formulata dallo stesso Leoni: “se si ammette che il potere delle organizzazioni dei prestatori d’opera sia legittimamente esercitato anche quando tende, per mezzo dello sciopero, ad influire sulla linea politica del governo, al di fuori del normale meccanismo delle elezioni”, scriveva Leoni (nel 1953!), “allora conviene accettare la sostituzione di quest’ultimo con un governo estemporaneo e irresponsabile dei sindacati”. Chi negherebbe un ruolo di crescente importanza, certo particolare ma ben presente e rilevante, del sindacato nella vita politica? Ma l’aspetto più disastroso della filosofia dello sciopero è la demolizione dell’autonomia individuale. Le astensioni dal lavoro trasformano in una guerra di trincea quello che sarebbe un normale rapporto di scambio (una prestazione lavorativa in cambio di un reddito). Il lavoro, infatti, non è un diritto dei lavoratori né tanto meno un obbligo dell’imprenditore. E’ solo una relazione fra persone e, come ogni rapporto, se io sono soddisfatto lo prolungherò. In caso contrario, ci si lascia. Abbandoniamo la teoria e torniamo allo sciopero dei giorni scorsi. Che è stato un grande successo. Grande partecipazione politica. Adesioni alle stelle. Eccetera. S’è detto tutto questo, e molto di più. Fermi un attimo, però: per che cosa protestavano i sindacati? Recitava, ammiccante, uno striscione: “Più salari, più diritti, più occupazione”. Ma non è forse la tela sempre più opprimente di diritti (privilegi, suona meglio), di restrizioni burocratiche sui licenziamenti e di salari spinti artificialmente verso l’alto ad aver costretto molte imprese a percorrere altri sentieri, ad andarsene dal nostro paese, a “delocalizzare” (brutta parola)? Hanno creato la malattia e, invece di curarla, pretendono di estenderla. Complimenti: se non altro, riescono ancora a strapparci un sorriso. 06 ottobre 2005 * Tiziano Buzzacchera è il titolare del blog Rothbard |
|
|
 |
|
|
|
||
|
|
||
|
I blog di Ideazione
|