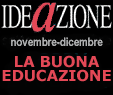|
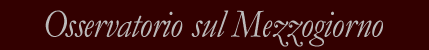
[IL DOCUMENTO DI BARI]
Oltre la congiuntura:
le cause di fondo del ritardo meridionale
I problemi strutturali del Mezzogiorno sono tre:
- l’esistenza di un marcato divario nel reddito pro capite
rispetto al Centro-Nord; alle origini del quale esiste un gap di
infrastrutture materiali e di beni pubblici intangibili;
- il carattere dipendente che l’economia meridionale è venuta
assumendo in seguito alle modalità operative delle politiche
adottate per correggere la dimensione del divario: modalità che,
dalla fine degli anni Sessanta, si sono sempre risolte in termini
di meri trasferimenti di finanza pubblica e non di aumento della
produttività endogena;
- l’assenza crescente di intermediari e mercati finanziari nel
processo locale di trasformazione del risparmio in investimento:
in ragione sia della scomparsa della proprietà locale nel
controllo degli intermediari che nella diffusa presenza dello
Stato nel processo effettivo di intermediazione.
I tre problemi generano un circolo vizioso che si accentua nelle
stagioni congiunturali: durante le quali il cambio italiano si
apprezza ed alla finanza pubblica vengono imposti rigidi vincoli
di stabilizzazione, perché la minore produttività locale,
combinata con l’apprezzamento del cambio, aumenta il gap nei
confronti dei prezzi internazionali, mentre la rigidità della
spesa pubblica comprime la domanda interna.
Nella crisi del 1992 precipitarono tre eventi, tutti gravidi di
conseguenze negative sull’economia meridionale.
La svalutazione della lira determinò un vantaggio relativo per il
sistema industriale del Centro-Nord, che era pronto e capace di
catturare l’opportunità di un dumping per sostenere le sue
esportazioni.
Si accumulò, grazie a quella manovra, nella prima metà degli anni
Novanta, un ritardo addizionale di crescita che azzerava i modesti
recuperi del divario tra le due Italie avvenuti nei decenni
precedenti.
Lo smantellamento del sistema di intermediari ed agenzie pubbliche
che sostenevano, mediante trasferimenti finanziari, il livello del
benessere ma non la capacità di produrre delle regioni al Sud,
determinò un vuoto deflattivo che, cumulandosi con l’incapacità di
cogliere le opportunità per esportare e con i costi derivanti dal
maggior onere delle importazioni, determinò, inoltre, una diffusa
crisi delle imprese meridionali e, nel giro dei due anni
successivi, la crisi generalizzata delle banche radicate nel
mercato meridionale.
L’ipotesi di riprendere la scommessa della crescita, solo dalla
dimensione locale e dalla capacità d’intervento degli enti
pubblici territoriali, enfatizzò una dimensione artigianale,
provinciale e pubblica delle modalità della crescita economica.
Proprio quando, con la crescente integrazione globale del mercato
mondiale, quella dimensione veniva percepita, al contrario, come
post-industriale, cioè ipertecnologica, integrata alla scala
dell’intera economia mondiale e sostanzialmente affidata alle
dinamiche di mercato ed alla responsabilità individuale.
Al gap nel tenore di vita e nelle modalità secondo le quali si
genera il livello di benessere – i trasferimenti di reddito e non
la capacità di competere sui mercati generando progressivamente
valore dalle proprie conoscenze e dalle proprie capacità – si è
aggiunto, in questo modo, un gap di cultura e di percezione delle
determinanti della crescita che ritarda, oggettivamente, il
processo di riallineamento tra le due sezioni territoriali del
Paese.
Tutti questi effetti sono intervenuti in maniera stringente nella
prima metà degli anni Novanta ed hanno determinato la crisi
definitiva del regime proprietario locale nel sistema degli
intermediari finanziari indebolendo radicalmente il sistema
produttivo locale.
Nella seconda metà degli anni Novanta si registra una lenta
ripresa della crescita che non ha, tuttavia, prodotto risultati
robusti nel lungo periodo dal momento che riproponeva la formula
di una finanza dipendente dai trasferimenti pubblici: anche se la
provvista di questa spesa veniva imputata, in parte, a fondi
provenienti dalle politiche regionali europee.
Un eccesso di retorica e enfasi sulle possibilità degli enti
locali di orientare la crescita ha determinato, in uno con i
motivi già detti, un’effervescenza di attività molto flebile che,
a fronte della crisi della crescita internazionale, lascia oggi,
ancora una volta, disarmata l’economia locale.
novembre
2002
|